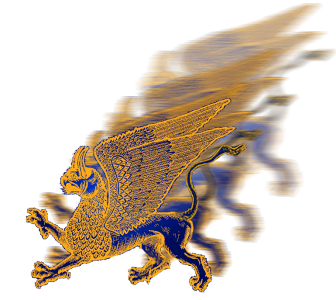Sembrerò crudele, ma preferisco chiamare le cose con il loro nome considerandole per quello che sono. Forse in altri momenti avrei fatto a meno di “illuminare” certe realtà e certe contraddizioni… ma c’è chi si fa tatuare l’Equazione di Dirac considerandola come l’Equazione dell’Amore. Al contrario, la verità è una sola, Paul Dirac formulò la sua NON equazione dell’amore o del Quantum entanglement: descritto in parole povere, il teorema riguarda una particella libera di muoversi nello spazio intergalattico, una particella del tutto sola, che non interagisce con altre e con nessun influsso o campo fisico (meno che mai metafisico e neppure amoroso… volendo fare un parallelo tra un essere umano e una meccanica particella subatomica).

Premessa – L’equazione di Dirac, radicata in considerazioni puramente teoriche, spiega perfettamente il moto e le proprietà degli elettroni, compreso il loro momento rotatorio intrinseco, lo spin, la cui descrizione aveva richiesto fino al 1928 (anno della formulazione di DIrac) ipotesi piuttosto artificiose.
Lo so, ho rovinato tutta la poesia, tutta un’immaginazione passionale che ha pervaso tanti per moltissimi anni, ma sono altrettanto consapevole che in molti, pur se arrivassero a leggere queste mie parole scritte, continuerebbero a considerarla l’Equazione dell’Amore.
Semmai, l’equazione porta con sé il trionfo della solitudine in quanto espressione di due entità, la particella e l’antiparticella, due realtà esistenti sì, ma specchi reciproci di “vite” opposte che non potranno mai incontrarsi pena l’annichilimento, la morte, la distruzione reciproca.
L’unica cosa vera, espressa da Paul Adrien Maurice Dirac, fisico teorico britannico nonché Premio Nobel per la Fisica nel 1933, è che proprio i teoremi fondamentali della fisica hanno una bellezza ma… matematica.
Non la bellezza amorosa, non la bellezza dell’aspetto umano o dei sentimenti.
“I modelli di un matematico, come quelli di un pittore o di un poeta, devono essere belli: le idee, come i colori o le parole, devono legarsi in modo armonioso. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c’è posto per la matematica brutta”.
“Apologia di un matematico”, saggio scritto dal matematico britannico Godfrey Harold Hardy (1940)
Dirac parlava della bellezza dei numeri, quindi della loro capacità di esprimere la realtà fisica dell’infinitamente piccolo, di particelle, antiparticelle, campi a energia negativa. Come sottinteso, un’impossibilità, a questi livelli, di esprimere o spiegare, neppure in scala elementare, passioni e affinità: non c’è nemmeno un parallelo con quanto teorizzato e spiegato matematicamente da Dirac.

Non entro nei tecnicismi matematici perché anche avendoli esaminati, diventa quasi una missione impossibile tradurli in linguaggio corrente.
Inizio da quanto ho scritto in premessa su questa pagina: l’equazione riguarda una particella libera di muoversi nello spazio intergalattico, una particella sola che non interagisce con altre e con nessun influsso, neppure in coppia con un campo elettrico, magnetico, energetico di qualche tipo.
Semmai, l’equazione denominata del groviglio quantistico (i∂–m)ψ=0, è in realtà una sorta di sistema di quattro equazioni. “Racconta” matematicamente il comportamento di particelle singole – se così posso definirlo senza sbagliare troppo – trovando il punto unificatore matematico/descrittivo in relazione alla meccanica quantistica e alla relatività ristretta o meccanica quantistica relativistica.
Mamma mia che paroloni! Ma questo è.
Era un problema che andava avanti dai tempi delle prime stesure fisico-matematiche di Albert Einstein, con le “aggiunte” (matematici e fisici mi picchieranno) di Klein–Gordon, di Schrödinger.
Paul Dirac trovò la summa di tutti spiegando matematicamente le grandi incongruenze fisico-matematiche rimaste sul campo fino a quel momento. Lo fece grazie alla sua celebre equazione che lui riuscì a formulare nel 1928 al St John’s college di Cambridge, da studente 25enne.
Mise insieme due elementi fondamentali: il comportamento delle particelle (gli elementi più piccoli esistenti, parte di atomi, dai quelli più elementari ai più grandi) e il loro comportamento in rapidissimo movimento (equivalente a quello della luce).
Unendo i due aspetti e descrivendo, infine, come agisce un elettrone alla velocità della luce, Dirac aggiunse due elementi di questa particella: il suo magnetismo e la sua “rotazione” o spin-momento angolare (per mia azzardata similitudine, è quello che consente a un monociclo o a una bicicletta di restare in perfetto equilibrio grazie alla rotazione-momento angolare delle ruote).
Quindi, la formula mette insieme più cose insieme a una grandezza/quantità immaginaria “i”, mentre la massa “m” ha segno negativo.

“L’equazione è più intelligente del suo autore”, queste le parole usate in un suo discorso da Dirac. Nel pronunciarle fu profetico perché questo rapporto matematico continuò poi a spiegare relazioni fisiche tra particelle e campi, portò alla considerazione di antiparticelle (stessa massa dell’elettrone, ma con opposta carica elettrica). Era la cosiddetta “antimateria” che, in una sua antiparticella fu poi scovata dallo sperimentatore Carl Anderson che stava analizzando le piogge di raggi cosmici che colpivano la Terra dallo spazio esterno.
In questo l’equazione poteva essere paragonata a una sorta di verità fisica rivelata con aspetti tutti ancora da scoprire ma già matematicamente spiegati. Sembra strano a scriverlo, ma questo è stata. Tornavano tutti i conti energetici e comportamentali delle particelle e dei campi-flussi.
L’Equazione di Dirac riguarda sistemi macroscopici, elementari, meccanici se posso azzardare il termine. Nulla di più lontano potrebbe essere anche solo immaginato per compararlo agli esseri umani e alle forze dei sentimenti e delle passioni.
Al di là di quanto compone la formula di Dirac, lo ripeto, questa racconta solo il comportamento di un solitario elettrone che vaga negli infiniti campi dell’universo, libero da qualsiasi legame con i suoi simili. Un invisibile navigante-eremita perso nell’inimmaginabile.
Dall’Enciclopedia Treccani: “C’è infine un’altra curiosa definizione di Dirac, noto per un aspetto della personalità, l’estrema riluttanza a parlare: i colleghi di Cambridge avevano coniato il dirac, una presunta unità di misura della loquacità: un dirac, nelle loro intenzioni, valeva l’emissione di una parola ogni ora”.