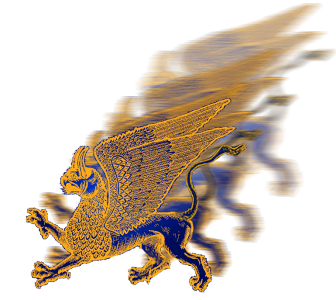La musica gli ha dato molto, lo accompagnato dal grembo della madre fino al trovare l’amore della sua vita, ai successi italiani e internazionali, alla cattedra che ultimamente ha ottenuto al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Alberto Ferro, giovane pianista siciliano, internazionalmente noto, nato nella musica: concerto solista il 25 febbraio per Trapani Classica. Palazzo D’Alì, ore 18 a Trapani, Sicilia (ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.trapaniclassica.it).
L’occasione dà modo di conoscere dal vivo l’arte interpretativa di Alberto Ferro, la sua capacità di creare note al pianoforte, strumento che è stato il suo mezzo espressivo fin da piccolo e da quando cominciò a muovere i primi passi nello studio della musica insieme alla madre.
L’intervista
Giuseppe Grifeo – Ho letto che hai iniziato a sette anni con al fianco tua mamma, Marisa Cafà. Anche lei pianista? Spiegami come è andata. Fin da piccolo ti eri innamorato della musica, avevi una passione per la tastiera, per il Pianoforte? Quale molla, quale spinta interna ti ha fatto iniziare e proseguire?
Alberto Ferro (link al suo sito web) – Dunque, mia madre si era diplomata a quello che poi divenne il Conservatorio di Caltanissetta. È stata proprio lei che mi ha dato le primissime lezioni. Per la verità mia madre mi ha sempre raccontato che già quando era incinta di me, lei ascoltava musica. Indirettamente, quindi, arrivava anche a me: metteva le registrazioni, oppure si metteva lei stessa a suonare il pianoforte.
Poi, da piccolissimo ho iniziato a considerare la musica come un giocattolo. L’approccio è stato del tutto naturale: tra i miei giocattoli avevo una passione per le costruzioni Lego e il pianoforte. La musica mi ha sempre accompagnato durante tutto il percorso educativo dell’infanzia.
G.G. – Dopo questo inizio, la formazione musicale e pianistica è cambiata evolvendo.
A.F. – Ho proseguito con un istituto musicale a Gela, il “Giuseppe Navarra”, convenzionato con il Bellini di Catania, poi Ribera e dopo con Palermo. Questa scuola dipendeva dal Comune: molti anni dopo ha chiuso a causa della crisi economica, nel periodo 2011-2012. Quando si verificano crisi del genere, i primi tagli vengono fatti proprio nel settore della musica. Lì avevo studiato fino al 2009, poi feci l’esame da privatista al Bellini di Catania dove ho conosciuto il mio mentore, il professore Epifanio Comis che mi ha guidato ufficialmente fino al 2019 per il conseguimento del diploma col vecchio ordinamento, poi laurea di secondo livello, ma soprattutto è stato prezioso nella preparazione e per le partecipazioni che mi hanno consentito di conseguire premi importantissimi in concorsi internazionali. Comis è stato determinante.
G.G. – La tua prima “avventura” all’estero quando e dove è stata?
A.F. – A Costanza in Romania con l’Orchestra del Teatro dell’Opera e il balletto. Devo quel momento al mio maestro e mentore, noto direttore d’orchestra: lì ho avuto modo di debuttare con il primo concerto di Rachmaninov. Era novembre del 2010. Per me un evento unico, ero all’estero debuttavo a 14 anni in un impegno interpretativo di forte livello. Iniziare a quell’età interpretando la musica di quel compositore, in quel Teatro, è stato come guidare una Ferrari da subito, da neo patentato, invece che guidare un motorino o una Cinquecento. Fu motivo di orgoglio e uno stimolo, tant’è che mi sono abituato sempre di più a suonare con orchestre in repertori difficili.


G.G. – Hai incrociato e conosciuto artisticamente grandi personaggi, ho letto anche di Vladimir Ashkenazy. Ma hai frequentato scuole per far evolvere la tua arte e vinto tanti premi.
A.F. – Sì, ho frequentato molti corsi di perfezionamento e ho avuto l’onore di lavorare con personaggi fondamentali della musica: sono stati preziosissimi. Lo stesso Vladimir Ashkenazy è stato anche al Complesso Le Ciminiere di Catania. Tra i traguardi primari il premio Concorso internazionale Busoni, per me cruciale, ma non fu il primo. Avevo già partecipato ad altri come a Verona, Taranto, in Danimarca, tutti a cavallo tra il 2014 e il 2015, molto significativi per la preparazione al Busoni. Ques’ultimo è il concorso internazionale più importante d’Italia, esistente già dal 1949.
G.G. – La tappa che ti ha visto conquistare la seconda posizione al Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, ha rappresentato il trampolino di lancio verso nuove esperienze.
A.F. – È stato un momento fondamentale per la mia vita. Mi ha permesso di debuttare poi in città importantissime, Roma, Milano, in Germania, ho ottenuto una rete di contatti con la Steinway & Sons, concerti anche in Belgio, alla Filarmonica di Lussemburgo, alla Gewandhaus di Lipsia solo per citarne alcune. Ed ero ancora piccolino, avevo 19 anni, ma non mi sono più fermato.




G.G. – Una grande corsa, un impegno costante e ambienti tra i più disparati dove storicamente si respira arte e musica.
A.F. – Non mi sono mai fermato anche perché a volte il rischio è quello di fare tutto prima, di bruciare le tappe per passare poi nel dimenticatoio. Ho continuato a fare concorsi, di continuo, come il Queen Elisabeth a Bruxelles nel 2015 fino al Beethoven di Bonn dove ho vinto il primo premio nel 2017.
G.G. – E i traguardi più recenti? Oltre ai concorsi a cosa ti dedichi?
A.F. – A aprile il Premio Jaén de Piano 2022 in Andalusia, Spagna, dove ho raggiunto la seconda posizione: concorso prestigioso, membro della World Federation of International Music Competition di Ginevra. Oggi continuo la mia attività concertistica e didattica.
G.G. – Quali sale di concerto ti rimarranno per sempre nel cuore?
A.F. – Senza ombra di dubbio, parlando di affezione, l’Herkulessaal a Monaco di Baviera perché grazie al concerto cui partecipai nel 2017, ho conosciuto colei che oggi è mia moglie, Erika Nahapetyan, violista: in quel momento lei faceva parte dell’orchestra, io ero solista. Il programma prevedeva il primo concerto di Shostakovich. Ci siamo innamorati subito, proprio in quel momento. Ci siamo sposati nel 2020. Altra sala che sta nel mio cuore è quella al Bozar di Bruxelles per il Concorso Pianistico Internazionale “Queen Elisabeth” alla presenza della Regina Mathilde. Distaccandosi poi dai teatri veri e propri, il mio recital del 2017 alla Cappella Paolina del Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella: evento molto emozionante.
G.G. – Insegnare adesso è uno degli aspetti fondamentali della tua attività. Progetti e obiettivi?
A.F. – Si, insegno Pianoforte principale al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e questo rientra nei miei obiettivi primari: mantenere la mia carriera concertistica e quella didattica. Da poco lavoro nei conservatori e spero di farmi conoscere di più come didatta. Ho insegnato prima a Foggia, poi a Messina e adesso al Conservatorio di Palermo.



Nel 2016 e nel 2017 Alberto Ferro ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, conferitagli per la Festa Europea della Musica dall’allora Presidente della Camera. Fu un riconoscimento dell’Assemblea dei Deputati al suo talento artistico e per i successi riportati nel corso degli ultimi anni in prestigiose competizioni pianistiche internazionali. Nel marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, nella rassegna “I Concerti del Quirinale” in diretta su Rai Radio 3, ricevendo tanti apprezzamenti dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
Da sottolineare che dopo l’appuntamento con Trapani Classica il 25 febbraio 2023, Alberto Ferro si esibirà il 21 e il 22 aprile al Teatro Massimo Bellini di Catania con il triplo concerto di Beethoven. Lo storico Teatro catanese lo ha già visto esibirsi più volte.
Qui di seguito il link al Curriculum-Biografia di Alberto Ferro in un file pdf (contiene testo in Italiano e in Inglese):
Programma del 25 febbraio a Palazzo D’Alì
- Fryderyk Chopin: Tre mazurke op. 59
- Claude Debussy : Preludio n. 7 – “La terrasse des audiences du clair de lune” dal 2° Libro L 131
- Franz Liszt: Rapsodia ungherese n. 12, S. 244
- Sergej Rachmaninov: Variazioni su un tema di Corelli op. 42
- Alexander Scriabin: Sonata n. 1 op. 6 – Allegro con fuoco – Adagio – Presto – Funébre
Guida all’ascolto, a cura di Annamaria Malerba, musicologa e docente di musica, segretario di “Trapani Classica”
– Sessanta mazurke attraversano la vita artistica di Fryderyk Chopin (1810 – 1849), dalle quattro mazurke opera 6 composte nel 1832 all’età di 22 anni alle ultime dell’opera 68 del 1855, senza considerare quelle senza numero d’opus alcune delle quali composte da uno Chopin appena adolescente.
Ciò è indicativo di quanto il compositore polacco fosse legato a questa forma compositiva dal carattere popolare. La mazurka è una danza ternaria della Mazowia, diffusa nella Polonia centrale, il cui nome deriva da mazurek o mazur, termine di origine russa. Più di altre forme, essa è l’espressione di quel recupero delle tradizioni popolari tanto caro alla cultura romantica.
Anche le Tre mazurke op 59 del 1845, come le altre, mettono in luce l’interesse vero di Chopin verso il mondo contadino della sua terra, verso il suo linguaggio e, in particolar modo, verso il canto popolare polacco. Pur incastrate in uno schema compositivo codificato (A-B-A), il compositore, attraverso particolari caratteristiche ritmiche, melodiche ed esecutive (ritmi e intervalli tipici, note ribattute, cromatismi…), richiama l’atmosfera folcloristica e, insieme ad elementi innovativi e sperimentali, reinventa la forma mantenendone il carattere tradizionale.
– Il Preludio n. 7 La terrasse des audiences du clair de lune di Claude Debussy (1862-1918) è inserito nella seconda raccolta di dodici Préludes, composti fra il 1911 e il 1912. Il termine “Preludio” qui non deve essere inteso come un’introduzione ad altro brano, piuttosto come un suggerimento o un’allusione. I preludi vogliono stimolare l’immaginazione ma non guidarla verso una direzione definita. Per questo, probabilmente, Debussy inserisce alla fine di ogni brano e non all’inizio titoli descrittivi e/o evocativi. Tutti i 24 preludi presentano forme libere ed appartengono all’ultima fase dell’estetica del compositore francese in cui la scrittura impressionista lascia il posto, a tratti, ad un linguaggio ancora più simbolico ed astratto. La terrazza delle udienze al chiaro di luna, un preludio lento ed enigmatico, presenta una particolare scrittura a tre pentagrammi che abbraccia una grande estensione sonora.
– Con le 19 Rapsodie ungheresi, composizioni libere e fantasiose, Franz Liszt (1811-1886) ha inteso omaggiare la musica tzigana compenetrata nella tradizione musicale dei magiari, convinto che l’origine della musica ungherese fosse propriamente tzigana e non semplicemente magiara. La Rapsodia S. 244 n. 12 in Do diesis minore dedicata al celebre violinista ungherese Joseph Joachim, evidenzia un carattere propulsivo ed una incredibile scrittura virtuosistica in cui attraverso ornamentazioni melodiche e ritmiche si susseguono diverse e colorate idee tematiche.
– Sergej Rachmaninov, come Liszt, manifesta mirabilmente l’altro aspetto dell’artista, l’essere cioè compositore oltre che interprete e concertista. La sua musica rappresenta la naturale continuazione del pianismo romantico di Chopin e di Liszt. Il tema portoghese, La Follia, su cui l’autore crea le venti Variazioni op. 42 in Re minore è antico e abbastanza “sfruttato” da compositori più o meno noti a partire dal XVI secolo.
– La Sonata n. 1 op. 6 di Alexander Scriabin (1872-1915) ha una genesi non felice. Concepita nel 1892 all’età di 20 anni in un momento di sconforto per l’infortunio alla mano e al braccio causato da un eccessivo studio al pianoforte, essa è “un grido contro il destino e contro Dio”, come scrive lo stesso autore. Un grido che esplode fin dalle prime battute e si protrae per quattro movimenti interrotto soltanto da qualche momento di religiosa speranza.