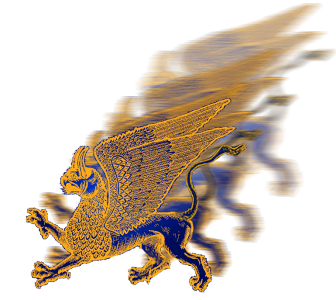È vero, sentire un compositore che parla di musica significa essere proiettati in un nuovo e differente punto di vista. Il Maestro Pietro Rigacci è personaggio di primo livello nel panorama musicale, disponibile, divertente, fa precedere solitamente i suoi recital/concerti da un confronto col pubblico su alcune delle soluzioni musicali scelte dai compositori, opere che lui andrà a interpretare. Il gusto della vita nella musica è presente con forza in un concetto che il compositore ripropone più volte: suonando si cerca di evocare atmosfere. Così farà a Trapani sabato 7 maggio per il suo recital nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì alle 19,30.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione musicale e culturale “Trapani Classica” presieduta dal Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti. Il tutto in concorso con l’Ente Luglio Trapanese – Trapani Capitale della Cultura, Assessorato alla Cultura della Città di Trapani.
(ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su www.trapaniclassica.it)


Pietro Rigacci è nato circondato dalla musica: “Mio padre, Bruno Rigacci, fu allievo di Casella per pianoforte e composizione, poi si esibì con grandi orchestre in celebri teatri in Italia e nel mondo. Zangarini, librettista de La Fanciulla del West” di Puccini, stava scrivendo il libretto per un’opera: c’erano Leoncavallo, Mascagni, Cilea, Casella, tutti che volevano farlo, volevano musicare il libretto. Ma Zangarini, lui sessantenne, non appena sentì la musica di mio padre appena diciottenne, affidò a lui quest’opera per musicarla. Mio padre passò le diverse fasi, da pianista a compositore, poi direttore d’orchestra e direttore d’opera. Questo amore, questo approccio e vita per la musica me li ha passati lui. Avevo dieci anni quando il babbo imparava un’opera e io ero seduto accanto a lui: me la spiegava tutta, ragionava con me. Con lui ho imparato tutto sul teatro dell’opera”.
“Babbo aveva sempre desiderato che io facessi il direttore d’orchestra. Lui me lo ripeteva e io rispondevo che invece volevo rapportarmi col pianoforte. Ebbe finalmente il piacere di vedermi con la bacchetta in mano quando ho diretto la mia seconda opera. Però, come ripeto sempre, le mie dita sono la mia orchestra. Come tale, quando sto suonando e devo timbrare in un certo punto, con il quarto dito do l’attacco a uno strumento. Babbo, l’ultima volta che diresse Traviata, nel 2007 a 85 anni, nel fare il preludio dell’opera, disse all’orchestra, “voi siete le mie dita: mi sembra di suonare un pianoforte”. L’orchestra pendeva dalle sue dita. Lui si divertiva, guardava la viola e muoveva il terzo dito della destra, poi col mignolo dava l’attacco ai contrabbassi per il pizzicato. È una testimonianza di un modo di vivere le cose in un mondo che sta perdendo valori in continuazione”.
Anche la madre di Pietro era nata e cresciuta nella musica: svedese di nascita, era la soprano Ulla Lindberg. E per dirla tutta, c’è anche Susanna Rigacci, sorella di Pietro, soprano svedese naturalizzata italiana: ha dato voce alle colonne sonore dei film di Sergio Leone come “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta il West”, “Giù la testa”, scritte e dirette da Ennio Morricone. Con lo stesso compositore ha tenuto diversi concerti in giro per il mondo. Dalla musica classica Susanna è passata alla moderna e contemporanea fino alla Operatic pop o pop opera (fusione tra la musica pop e l’Opera).
Pianista, concertista e compositore, il fiorentino Pietro Rigacci sarà il protagonista del nuovo concerto di “Trapani Classica” fissato al 7 maggio. È figura ben nota nel panorama musicale nazionale e internazionale, ha effettuato molte incisioni per la BBC a Londra, per la RAI, per la Radio Svizzera, Irlandese e Norvegese. Ha suonato con le più prestigiose orchestre del mondo e nelle più conosciute sale da concerto europee e americane oltre che in festival internazionali.
Oltre 220 registrazioni video live dei suoi concerti sono visibili sul canale Youtube “Pietro Rigacci Live Concerts” (link).
Rigacci è stato scelto dal presidente di “Trapani Classica”, il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, concertista trapanese di fama internazionale che, ancora una volta, ha pescato nelle sue relazioni tra i grandi artisti e professionisti per impreziosire e rendere unici gli appuntamenti trapanesi con la musica classica.
Programma del concerto trapanese di sabato 7 maggio 2022
– Fryderyk Chopin – 3 Mazurke op.59
- n.1 – in La minore Moderato
- n.2 – in La bem. maggiore Allegretto
- n.3 – inFa# minore Vivace
Barcarolle op.60
Polonaise – Fantasia op.61
– Aleksandr Scriabin
Studio op.2 n.1 in Do# minore Andante
12 Studi op.8
- n.1 – in Do# maggiore Allegro
- n.2 – in Fa# minore A capriccio, con forza
- n.3 – in Si minore Tempestoso
- n.4 – in Si maggiore Piacevole
- n.5 – in Mi maggiore Brioso
- n.6 – in La maggiore Con grazia
- n.7 – in Si bem. Minore Presto tenebroso, agitato
- n.8 – in La bem. Maggiore Lento, tempo rubato
- n.9 – in Sol# minore Alla ballata
- n.10 – in Re bem. Maggiore Allegro
- n.11 – in Si bem. Minore Andante cantabile
- n.12 – in Re# minore Patetico
Pietro Rigacci: l’intervista

Pietro Rigacci – “Ho grande piacere di venire in Sicilia, del resto manco dall’Isola da diversi anni. Oltretutto, Trapani mi mancava ancora. Sono stato più volte in Sicilia negli anni, da un concerto del 1978 a Marsala a Palermo negli anni 90 con concerti da solista con la Sinfonica Siciliana, quando c’era ancora il Maestro Pagano e concerto di Scriabin”.
Giuseppe Grifeo – E per l’evento di Trapani Classica del 7 maggio, concerto che segna il suo ritorno nell’Isola, cosa ha preparato?
P.R. – “Riflettendo su un’opera, analizzandone i motivi e i perché, mi diletto a immaginare come sarebbe orchestrarla. C’è tutta una ricerca di linee che mi diverte da morire. Il programma che ho scelto per Trapani Classica è proprio visionario: c’è la prosecuzione dei procedimenti chopiniani e lo Scriabin prima maniera, quello che era lo Chopin russo. Lo stesso Scriabin nell’impiego degli accordi, nella maniera di cogliere e porgere un accordo particolare come fosse un bonbon che sta lì e dà piacere, dà appagamento. Nel programma del recital per il 7 maggio a Trapani mi è piaciuto inserire le diciture degli studi. Uno di questi studi si chiama “piacevole”: già così ti mette nello stato d’animo adatto. Come si traduce “piacevole”? Il viso si illumina subito, il respiro diventa profondo, come mettersi all’ombra di palme su un’amaca sentendo la brezza marina, tipico di momenti di contemplazione: suonando si cerca di evocare atmosfere”.
G.G. – Quando ha iniziato “sul serio” e che rapporti ha avuto con i suoi allievi?
P.R. – “Quando ho iniziato a insegnare avevo 22 anni a pochi giorni dai 23, nel novembre 1977 ed ero a Firenze: gli allievi di oltre metà classe erano più vecchi di me. I direttori del Boccherini sono stati tutti miei allievi. Molti sono andati al Royal College. Mi sono sempre rapportato con loro in maniera amicale e quando ci incontriamo periodicamente, sembra di conoscerci da sempre. Passano dieci anni e gli allievi iniziano a darti del “lei”, poi si sposano, passa la generazione, arrivano quelli più piccoli che ti dicono “lei ha l’età di mamma e papà”. Lì ti accorgi dello scarto generazionale. Ho insegnato per 45 anni e molti mi hanno dato grandi soddisfazioni”.
G.G. – Pianista, poi compositore. Una vita artistica articolata.
P.R. – “Inizialmente avevo dato forte avvio alla mia carriera di pianista. Eppure, i due diplomi di pianoforte e composizione li ho conseguiti a distanza di un anno l’uno dall’altro. A 23 anni ero già stato chiamato come solista dell’opera di Berio in prima assoluta al Maggio musicale, avevo i primi cinque minuti dello spettacolo sulle mie spalle, tutto da solo. Sicché ero proprio lanciato alla carriera pianistica. Poi approdai al Conservatorio di Lucca e mi divertii tanto a fare composizione”.
G.G. – Perché questa spinta verso la composizione e cosa ha aggiunto nel suo approccio alla musica?
“Perché è una maniera del tutto diversa di ragionare sulla musica. Nei miei 45 anni di insegnamento il passaggio e il confronto con tutti i miei allievi mi ha aiutato e mi ha spinto proprio a ragionare sempre più profondamente sulla musica. Serve tutto un percorso per comprendere l’arcano che si nasconde dietro il pensiero di un compositore, il perché questi fa una determinata scelta, perché scrive in una certa maniera, perché sceglie un determinato suono invece di un altro, perché improvvisamente dà a una nota quell’accento. Insomma, tanti piccoli dettagli che rappresentano quegli spunti d’analisi per cui si ragiona, quei punti che mi permettono di seguire la mia rotta, di fare del tutto miei quei pezzi entrandoci dento. Altrimenti non riuscirei a suonarli. Da pianista e, ancora di più, da compositore, devo riuscire a capire il meccanismo che ha portato al ragionamento della partitura. Devo comprendere tutti i perché dei compositori. Dopo la formazione con la Maria Tipo, quindi la grande scuola napoletana, il meglio, ecco il cammino personale fondendo le esperienze compositive. Ogni volta che studiavo un pezzo, ne discutevo con i ragazzi. Quando ho debuttato con la 106 a Lucca, l’ho dedicata a a tutti gli allievi che ho avuto in quarant’anni perché se riesco a capire questa fuga è perché per quattro decenni ho dovuto stare lì a riguardare le bucce a dei giovani che volevano trovare delle soluzioni che erano un pochino oltre le righe, riuscire a vedere cosa era accettabile e cosa non lo era, come potevano migliorare le idee. Non è un approccio accademico: si cresce e si vive assieme, ognuno fa le sue esperienze e ci si confronta”.
G.G. – È proprio un altro approccio e un altro tipo di approfondimento sulla sequenza delle note.
“Pensi che nel 1976, non ero ancora diplomato in Composizione, avevo vinto il Concorso di Treviso, fu l’anno dopo la vittoria di Roberto Cappello (1975) che invece nello stesso mio anno vinse il Busoni. Quindi, quando arrivai a fare il Concorso di Treviso, tutti a dire, “eccolo il vincitore di Treviso e di Busoni”, quindi con delle aspettative pazzesche. Risultai primo. Feci l’ottava sonata di Prokofiev. Uno dei grandi personaggi di cultura, il Maestro Mario Messinis, critico musicale che scriveva sul Gazzettino, personaggio che disse, “Rigacci suona da compositore”: riconobbe la particolarità, la mia caratteristica. Pensando a un’opera, analizzandone i motivi e i perché, mi diverto a pensare come sarebbe orchestrarla. C’è tutta una ricerca di linee che mi diverte da morire”.

G.G. – Volendo spiegare ancora di più, magari con un parallelo, cosa vuol dire studiare composizione, essere compositore?
P.R. – “Quando i ragazzi iniziano a studiare composizione, io faccio un paragone con la cucina. È come uno chef che deve dire quando si impiega lo zafferano in una ricetta, che fa ricerca sui gusti e sul loro impiego perché siano peculiari per una fusione perfetta dei sapori. Stessa cosa va fatta per le note che fanno parte degli accordi, per le sfumature. Bisogna evocare sensazioni. Come quando si prende il viso di un bambino carezzandolo: la mano prende già in aria la forma del viso, poi magari non lo sfiora nemmeno. È identico per la musica con i suoni, le appoggiature, le note che fanno parte dell’armonia e quelle che non lo sono”.
G.G. – Un passaggio per nulla semplice la composizione: preparazione? Abilità innata? Per lei cosa è la musica?
P.R. – “Il passaggio deve essere fatto bene, occorre tecnica e un’ampia gamma di conoscenze e approcci. Dopo deve esserci quel momento, quel trasporto, quell’elemento ineffabile che ti prende. Ritengo che la musica sia come un rito. È un rituale. Quando devi suonare, quando devi comporre, devi creare quell’atmosfera: il momento della musica è un rito. Naturalmente occorre anche il rapporto col pubblico, la creazione di quel magnetismo che è qualcosa di intraducibile e che rende ogni serata diversa dall’altra”.
G.G. – Sensibilità, interpretazione, ricerca di una chiave personale dopo aver compreso fino in fondo il linguaggio di un autore: così un brano rispetta lo spartito e la personalità creativa di un pianista pur… “cambiando pelle”?
P.R. – “Quando stavo facendo l’integrale delle Sonate di Ludwig van Beethoven, capitò, come sempre accade, il momento di fare anche l’opera 106 “Hammerklavier”, questa sonata immensa: mi fu chiesto di essere presente a Firenze in un ambiente che di norma era una sala d’ascolto per musica Jazz. Lì proposi la 106. Alla prova al pianoforte il titolare della sala rimase perplesso e mi chiese, “lei esegue solo questo?”. Risposi di sì, aggiungendo che doveva tener presente una mia caratteristica, amavo dialogare col pubblico, spiegare la composizione parlando di musica, di sensazioni, spiegando i temi, facendo sentire delle soluzioni, delle armonizzazioni di una melodia, procedimenti normali che avrebbero fatto compositori dell’epoca per poi far ascoltare cosa fece Beethoven in modo da far capire la peculiarità di certe soluzioni. Arrivò il concerto, sala confortevole dove il pubblico poteva anche mangiare qualcosa e bere. Iniziai il mio dialogo con la gente… c’era il silenzio più assoluto. Nessuno sgranocchiava nulla, non un rumore di sedia spostata, nulla. Iniziò la sonata. Alla fine del terzo tempo, questo adagio immenso da 25 minuti in cui mi ero divertito a fare quelle timbrature come campane, il pianoforte che aleggiava nella stanza, dopo l’ultimo accordo il suono che andava sempre più lontano, lontano… io fermo immobile e nessuno fiatava. Mi preparai per l’ultimo movimento in questo silenzio assoluto, un mezzo minuto come in apnea. Dopo, finito il concerto, tornò da me il titolare della sala, quello che era rimasto perplesso alla prova. M disse: “È possibile che un’interpretazione possa cambiare un pezzo dal bianco al nero?”. Gli risposi di sì. Questi sono gli elementi venuti in luce e di cui mi piace discorrere anche con l’amico Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, perché proprio su questi temi è come se fossimo due gemelli, ci danno molto piacere e nei nostri repertori facciamo gli stessi brani. Come nel nostro primo incontro de visu, parliamo continuamente di tutti questi aspetti, del rapporto con la musica, dei percorsi di ricerca e scoperta”.
G.G. – C’è stato un momento particolare in più, un passaggio che le ha stimolato la mente e che l’ha indirizzata stilisticamente?
P.R. – “Forse la cosa che mi ha proprio aperto la mente, a parte il lavoro su Bach, è stato quando ho approfondito il teatro mozartiano. Quindi, cosa sapeva fare Mozart con le tonalità, come impiegare tutte le cadenze, le pause per sapere delineare i personaggi: tutta la situazione drammaturgica è una cosa meravigliosa. Mi sono divertito tantissimo quando ho fatto un corso per docenti di evoluzione dell’Opera, da Monteverdi fino a Stravinskij, facendo vedere attraverso Wagner tutte le varie simbologie e particolarità. Sulla musica strumentale ho iniziato con Beethoven e tutta l’integrale, andando in ordine cronologico, vedendo dove la mente del compositore cambiava i formulari andando alla ricerca di nuove soluzioni osservando tutto sotto un profilo teatrale: un Beethoven sconvolgente”.
Vita, traguardi e successi: il curriculum del Maestro Pietro Rigacci
Pianista concertista e compositore nato a Firenze nel 1954, consegue allo stesso tempo, con la massima votazione e la lode, i diplomi di Pianoforte (sotto la guida di Maria Tipo) e di Composizione (con Carlo Prosperi) al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. All’età di 23 anni ottiene la cattedra di Composizione all’Istituto Musicale “Boccherini” di Lucca.
La sua carriera artistica si è sempre alternata tra la figura del concertista e quella del compositore.




Da compositore, essendo in netto contrasto con l’avanguardia sperimentalista degli anni 70, deve attendere gli anni 90 per trovare spazio nella programmazione artistica di un certo rilievo. Il suo mondo espressivo è imperniato nei concetti “armonia-melodia-ritmo”, radici formali nella classicità, che rilegge in chiave contemporanea con sfumature timbriche post-impressioniste, e richiami al mondo arcaico.
Inizia la carriera pianista vincendo nel 1976 cinque Concorsi, tra cui il Premio Pescara e il Premio Treviso, cui fa seguito il Concorso “Pozzoli” che vince nel 1977. Significative le successive affermazioni al Concorso Pianistico di Lisbona (1979), al Concorso Clara Haskil (1979) e al “Dino Ciani” nel 1980. Viene scelto da Luciano Berio come “pianista in scena” nella prima mondiale della sua messinscena “OPERA” al Maggio Musicale Fiorentino e in seguito anche ne “LA VERA STORIA” al Teatro alla Scala di Milano, nonché per l’integrale delle Sequenze incise per la RAI.
Ha effettuato molte incisioni per la BBC a Londra, per la RAI, per la Radio Svizzera, Irlandese e Norvegese, nonché suonato con le più prestigiose orchestre, nelle maggiori sale da concerto europee ed americane, e Festival internazionali.
Le conoscenze compositive lo hanno portato inoltre ad effettuare Masterclass sulla produzione musicale di Scriabin, del quale è uno dei massimi specialisti, di Messiaen.
Ha inoltre effettuato l’Integrale delle 32 Sonate di Beethoven, anche in forma di approfondimento stilistico-compositivo con lezioni-concerto.
Contemporaneamente a una brillantissima carriera pianistica, si è anche dedicato alla composizione, con opere commissionate e trasmesse da varie radio europee.
La sua composizione “Claire” per vibrafono, presentata nel 1997 in prima assoluta alla Radio Svedese, è stata eseguita alla Sala Filarmonica di Berlino nel 2000 e incisa in CD. Questo brano fa parte della serie 26 evocazioni su nomi di donna per strumenti solisti, tra cui Dejanira (contrabbasso), Estrella (arpa), Flora (organo), Grayce (Corno inglese), Moana (oboe), Lucrezia (violino), Ulla (ottavino), Yvonne (pianoforte), Zoraide (violoncello).
Nel 1997 la Sveriges Radio gli commissiona inoltre i “Three Canterburian Portraits” per voce e cymbalom.
Nel 1998 la Associazione Musicale Lucchese gli commissiona il settimino “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, in omaggio alla popolazione della città di Sarajevo devastata dalla guerra, per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, vibrafono e pianoforte.
Nel 2001 riceve dalla presidenza svedese di turno alla UE, la commissione di un brano, il “Four Songs for Alice” eseguito nel Salone della UE a Bruxelles.
Nel 2003 il Festival di Musica da camera di Bastad (Svezia) gli commissiona la “Elegia quinta” per oboe e vibrafono, trasmessa in diretta alla radio svedese.
Nel 2007 è stata rappresentata la sua prima opera lirica in 3 atti, “Sogno di una notte di mezza estate”, su libretto di Debora Pioli, commissionata dalla International Opera Theatre di Philadelphia, ispirata all’omonima commedia di Shakespeare.
Nel 2010, su commissione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, è stato eseguito in prima assoluta il poema lirico “L’arpa d’oro” per soprano, coro e orchestra. Del 2011 è il suo Concerto per marimba e orchestra.
Grande successo ha anche avuto il concerto per pianoforte e orchestra, pieno di citazioni operistiche: “Concerto 1813 – Omaggio a Verdi”, scritto in collaborazione con il padre Bruno Rigacci (autore del primo e secondo movimento). Nel 2014 dirige a Firenze la sua seconda opera “Magiche rime arcane”, visione allegorica in un atto, su testo di Rodolfo Tommasi, commissionata dall’Accademia Europea di Firenze, in cui antichi miti primari dell’Uomo vengono evocati in un fantastico ambiente rinascimentale fiorentino.
Recital del Maestro Pietro Rigacci
Sala Sodano di Palazzo d’Alì a Trapani
Sabato 7 maggio 2022 alle ore 19,30
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.trapaniclassica.it
Contatti
Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, presidente dell’Associazione Trapani Classica
+393386199250
spazio Facebook: https://www.facebook.com/trapaniclassica
email: