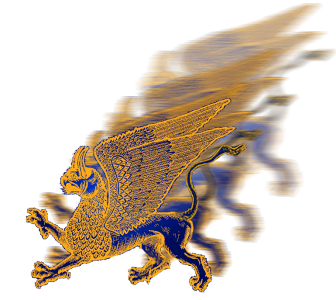Nello spazio, per mancanza d’aria, un suono classico come una voce, un veicolo, il frusciare di foglie, il ritmo delle onde marine, non può essere diffuso né sentito. Ci sono però altre vie. Il grande protagonista del nostro sistema planetario diffonde la sua voce. La pulsazione del Sole è forte, presente, un suono elettronico continuo e lo fa da cinque miliardi di anni. Probabilmente con ritmi differenti a seconda delle sue passate stagioni, dalla sua nascita all’attuale mezz’età.
Mi ci sono imbattuto rivedendo alcuni filmati dal sito web della Nasa e li ho rintracciati in libera diffusione anche su YouTube.
Il Sole, fonte di quel calore e di quell’energia che ci fanno vivere e che hanno stimolato la formazione della vita sul nostro pianeta, sta isolato, immerso nello spazio freddo e nero, pur se in compagnia (lontana) dei pianeti che ha legato a sé.
Consiglio di ascoltare il suono di questo video con le cuffie: l’effetto è moltiplicato, l’immersione è totale come nelle emozioni che riesce a suscitare.
Come sottolinea la stessa NASA dalle pagine del suo sito web, “I dati dell’ESA (Agenzia spaziale europea) e del Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) della NASA hanno catturato il movimento dinamico dell’atmosfera del Sole per oltre 20 anni. Oggi possiamo sentire il movimento del Sole – tutte le sue onde, loop ed eruzioni – con le nostre orecchie. Questo suono aiuta gli scienziati a studiare ciò che non può essere osservato ad occhio nudo”.
Alex Young, direttore associato scientifico nella divisione di Scienze eliofisiche al Goddard Space Flight Center della NASA: “Il Sole non tace. Il ronzio basso e pulsante del battito cardiaco della nostra stella consente agli scienziati di scrutare all’interno, rivelando enormi fiumi di materiale solare che scorrono davanti ai loro occhi… ehm, orecchie. Le onde viaggiano e rimbalzano all’interno del Sole e se i tuoi occhi fossero abbastanza sensibili potrebbero effettivamente vederlo”.
Il Sole vive nel continuo rimescolamento della sua stessa essenza. È una centrale atomica che cerca e trova continui equilibri tra l’energia creata, quella espulsa, tra il materiale e il plasma spinto verso la superficie e quello che sprofonda all’interno per l’immensa forza di gravità che tutto cattura e riporta verso il centro.
Un brodo infernale che innesca proprio quei processi di fusione atomica che fanno della nostra stella quel che è grazie a pressioni impensabili, calore e radiazioni.

Nell’immagine qui sopra si vedono punti luminosi, anelli e archi luminosissimi di materiale solare che volteggiano nell’atmosfera solare e, a volte, la superano. Queste aree così spettacolari sono quelle che vengono indicate come regioni attive sul Sole: sono punti caratterizzati da forti campi magnetici contorti che intrappolano particelle calde e cariche (plasma) rendendole più calde e spesso più dense delle aree circostanti; aree che appaiono luminose nelle immagini ultraviolette estreme.
Come rimarcano all’Agenzia spaziale statunitense, quando i campi magnetici si attorcigliano, poi si allungano e si sollecitano finché non si spezzano e si ricollegano in una configurazione più semplice. Le eruzioni solari, come i brillamenti e le espulsioni di massa della corona solare, sono spesso associate a regioni attive, anche se è ancora una questione scientifica in sospeso comprendere il come e il quando una particolare regione attiva deve eruttare.
“Sappiamo che è l’interazione tra i campi magnetici a innescare il bagliore, ma stiamo ancora cercando un modo per integrare la nostra teoria e le nostre osservazioni per essere in grado di prevedere esattamente quando si verificherà un’eruzione e quanto sarà forte”, ha sottolineato Michael Kirk, scienziato specializzato nel Sole al Goddard Space Flight Center della NASA.
L’ultima evidenza comunicata dai ricercatori della missione Parker Solar Probe a gennaio 2023 riguarda i punti d’origine del celebre vento solare, un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. È una sorta di corrente che va in ogni direzione e irradia tutto il nostro sistema planetario: è fatto di elettroni, protoni e ioni più pesanti che corrono a oltre 1,6 milioni di chilometri l’ora.
Immaginatevelo come un “particolare” vento, molto forte e senza fine, che soffia sulla superficie del mare.
(foto qui in basso: credit NASA/SDO/GOES-R – abbiate pazienza, ci mette un po’ a caricarsi: è una gif animata da 18,3 MB. Cliccateci sopra se volete osservarla più in grande).

In breve, il vento solare è in gran parte alimentato da getti su piccola scala (solo poche centinaia di chilometri, ma con enorme energia e massa collettiva) o “jetlets” che stanno alla base della corona, l’atmosfera superiore del Sole.
Questo vento cambia. Generato da tante piccole ma potenti fonti singole, la sua emanazione energetica è in origine discontinua, pulsante, intermittente. Solo dopo diventa un flusso costante, “più o meno allo stesso modo in cui i singoli suoni di un applauso all’interno di un auditorium diventano un ruggito costante quando il pubblico applaude”, ha raccontato Craig DeForest, fisico solare al Southwest Research Institute di Boulder, in Colorado.
Questa scoperta sta aiutando gli scienziati nel tentativo di risolvere gli enigmi che riguardano ciò che riscalda e accelera il vento solare.
“Questi nuovi dati ci mostrano come il vento solare si muove alla fonte. Puoi vedere il flusso del vento solare che sale da minuscoli getti di plasma a milioni di gradi su tutta la base della corona”.
Nour Raouafi, responsabile dello studio e scienziato del progetto Parker Solar Probe al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL)
Analizzare il vento solare e la sua origine fa comprendere meglio i tanti meccanismi che stanno alla base dell’esistenza del nostro sistema solare. Inoltre, farà intuire molte più cose sui sistemi planetari che andremo a scoprire.