Si fa presto a dire “Spazio”, ma dietro c’è un mondo complesso, colmo di lavoro e di opportunità in continua espansione. Space Economy quindi, una galassia che genera ricchezza, fatta di ricerca, sviluppo e infrastrutture per operare nello spazio -con e senza presenza umana-, una realtà che fa nascere servizi, applicazioni e prodotti rivolti sia al cosmo che alla Terra, anzi, molto terrestri. Un indotto colossale dedito a più comparti, come lo studio del nostro pianeta, delle sue risorse a cominciare da quelle idriche, forestali e agricole, il livello di inquinamento in ogni zona del mondo, la creazione di reti sanitarie, le telecomunicazioni e tantissimo altro.
Un racconto fatto dal professore Giorgio Petroni attraverso una mia intervista, personaggio che ne ha scritto anche nel suo libro “Space Economy: from science to market” (link ibs – link Amazon – link Cambridge) in tandem con Barbara Bigliardi, accademica dell’Università di Parma, edito da Cambridge Scholars Publishing.

D’altra parte, chi meglio del professore Petroni poteva e può scrivere-descrivere questo mondo. Nato a Cagli (Pesaro), da circa 60 anni risiede a Milano, è stato uno dei protagonisti all’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana, oggi all’INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica e, prima ancora, tra i personaggi principali di grandi realtà produttive italiane.
Ansaldo, Rinascente, Mondadori, Montedison tra le sue esperienze operative. Come accademico, fautore del primo corso di laurea in Ingegneria Gestionale (oggi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale) all’Università di Cosenza. Poi titolare di cattedra a Udine, tra i fondatori dell’Istituto Nazionale di Formazione Assicurativa, rettore dell’Università di San Marino dove ha dato vita a corsi per l’Ingegneria Gestionale, per l’Industrial Design e il comparto Comunicazione con Umberto Eco come protagonista.
L’approdo di Petroni allo Spazio e all’Asi avvenne sotto la presidenza dell’Ente da parte di Sergio De Julio: “Gli ingegneri si erano occupati poco degli aspetti economici dello Spazio, così iniziai a lavorarci, anche se inizialmente fui incaricato del trasferimento tecnologico”, ricorda il professore.
Come evidenziato anche nel suo volume, il tema dominante riguarda la dimensione economica delle attività dello Spazio, quindi investimenti, ritorni, sistema industriale, prodotti, servizi, occupazione, un grande sistema che ha avuto la sua prima scintilla con la corsa allo Spazio che sfociò nel 1957 e la messa in orbita del primo satellite artificiale, il russo Sputnik. Da quel momento lo sviluppo acquisì sempre maggiore velocità coinvolgendo sempre di più il tessuto produttivo.
Nel 2018 il fatturato complessivo del settore è stato di 329 miliardi di dollari, oltre la metà generato dalle applicazioni satellitari per le telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra. Come da rilevazione Space Report di Space Foundation, il traguardo dei 423 miliardi di dollari è stato raggiunto nel 2019 (il settore commerciale del comparto ha fatto registrare entrate pari a 336,89 miliardi di dollari).

Secondo il rapporto 2020 del Mise. la Space Economy è stata capace di generare 370 miliardi di euro di valore (l’80% riconducibile ad attività commerciale e il restante a spesa pubblica) che si stima diverranno oltre 500 entro il 2030. A oggi impiega un milione di addetti in tutto il mondo e ha un valore “di ritorno sugli investimenti” molto alto: per ogni euro speso, ne vengono creati 11.
La previsione di BOA-Merrill Lynch traccia un’ipotesi di crescita del settore pari a 8 volte nei prossimi 30 anni con un fatturato complessivo della Space economy lanciato verso i 2,7 trilioni di dollari nel 2045.
In Italia nella Space Economy sono coinvolte oltre 200 aziende, l’80 per cento delle quali sono di taglia medio-piccola. Il giro d’affari comunicato a novembre 2020 era pari a 2 miliardi di euro. Sono 7.000 gli addetti del comparto italiano con una crescita del 15% negli ultimi 5 anni.
L’intervista
Giuseppe Grifeo – Professor Petroni, quando si è manifestato concretamente il suo amore per lo Spazio?

Giorgio Petroni – Tutto ebbe un suo germe iniziale con il problema delle acque. In Italia, per esempio ne sprechiamo la metà per la decrepitezza della rete di distribuzione. In più, l’acqua iniziò a venir meno, fenomeno ben evidente adesso, per esempio in Pianura Padana. Per poter valutare le risorse idriche disponibili oggi si adoperano molto i satelliti i quali, nell’ambito dei servizi di osservazione della terra, danno parametri assolutamente affidabili. Per esempio, nel dare la misura della quantità d’acqua disponibile nelle Alpi, nei ghiacciai. Come avvenne il mio incontro con lo Spazio? Quando ero in Calabria conobbi un collega, all’epoca un giovane Sergio De Julio, arrivato da Roma, quando demmo forma al corso di Ingegneria Gestionale a Cosenza. A Roma la figura di riferimento nel campo era Antonio Ruberti, che fu ministro. De Julio era stato suo allievo. Tempo dopo, nel 1996 lo stesso De Julio fu nominato presidente dell’ASI, chiamato all’incarico dall’allora ministro Luigi Berlinguer: in quel momento Sergio mi chiese di poterlo aiutare nel consiglio di amministrazione. Da quell’istante sono rimasto in questo interessantissimo mondo dello Spazio e dell’Agenzia Spaziale Italiana.
G.G. – Una passione che è diventata così forte da portarla avanti anche dopo il suo incarico all’ASI.
G.P. – Sì, le tecnologie e lo Spazio erano una grande passione così, tra il 2001 e il 2002, continuai al CNR che aveva una sezione che si occupava di Astrofisica, sia dal punto di vista scientifico che tecnologico. Ho studiato molto e ho portato avanti molti approfondimenti scrivendo articoli fino ad arrivare al libro. Proprio sulla Space Tecnology rivolsi la mia attenzione agli aspetti economici, quindi sulla rilevanza e sulla dimensione economica dello Spazio, punti così poco curati dagli ingegneri del settore. Era un terreno importante da sviluppare. Io che avevo un’educazione economico-organizzativa, presi la palla al balzo e su questo tema iniziai a scrivere diversi articoli, tutti sulle maggiori e più note riviste scientifiche che trattano temi sullo Spazio. L’ASI poi mi incaricò di seguire il comparto del trasferimento tecnologico. Per fare ricerca c’è sempre posto, anche quando si diventa poi professori in pensione.
G.G. – Poi, ecco arrivare un’altra svolta, quella dell’INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica.
G.P. – Si, nel frattempo era nato proprio l’INAF. Non ho fatto altro che mettere insieme gli osservatori astronomici italiani, che prima dipendevano dal ministero dell’Università e della Ricerca, con le strutture del CNR che si occupavano di Spazio. Ed ecco che prese vita l’Istituto Nazionale di Astrofisica. Lì ho avuto e ho il mio posto, nella sede di Milano e, cosa preziosa, a disposizione c’è la sua ricca biblioteca.
G.G. – Dopo aver tanto trattato di Economia e Spazio, come è avvenuto il contatto con l’Università di Cambridge, fattore che l’ha spinta a scrivere il volume “Space Economy: from science to market”?
G.P. – Cambridge ha due case editrici, una per gli studenti e l’altra per gli scholars, per i ricercatori: la Cambridge Scholars Publishing. Da quest’ultima mi hanno chiamato. Riassumo il contenuto della chiamata: “Abbiamo visto che tu conosci molto bene questi problemi di economia dello Spazio, perché non ci scrivi un libro?”. Questo è stato il loro invito. Tutto è nato naturalmente da notizie che, come sempre, circolano, da accademici e ricercatori che leggono, meditano sugli studi diffusi dalle riviste scientifiche. Avevano quindi notato i miei articoli precedenti e altri miei lavori. E qui voglio rimarcare un punto: nella ricerca e negli approfondimenti, gli italiani sono tutt’altro che gli ultimi. Vengono letti, notati, studiati. È cosa ben nota.



Si fa presto a dire “Spazio”: sviluppo, impresa ed economia. Come e chi fa business?
G.G. – Lo Spazio è estremamente noto, soprattutto fra l’opinione pubblica, per le imprese spaziali, le missioni lunari, le sonde lanciate per lo studio del sistema solare, la recente missione su Marte, la preparazione della prima missione Artemis. solo per citarne alcune. Però c’è tanto altro di più, un aspetto molto più rivolto alla Terra, capace di portare grandi benefici, conoscenza del pianeta sotto vari aspetti e ricadute importanti sul tessuto imprenditoriale, sullo sviluppo di startup e sulla vita quotidiana.
G.P. – Giustissimo. È un aspetto da sottolineare bene. Che cos’è questa economia dello Spazio? È tante cose ma, fondamentalmente, i punti principali sono questi. Un sistema spaziale va diviso in due parti. Uno è l’Upstream, il sistema che consente all’uomo di volare nello spazio, l’outer space, quello spazio che sta al di sopra dell’atmosfera, convenzionalmente indicato a una quota di cento chilometri dal livello del mare: per arrivare a questa altezza e per continuare a navigare tra pianeti o orbitare attorno alla Terra, c’è un complesso tecnico molto preciso, appunto l’Upstream costituito da un lanciatore, un razzo che ti mette in orbita, un satellite e una stazione di terra, la ground station, che raccoglie i segnali inviati dal satellite. Questa è una prima dimensione economica perché tutte queste cose devono essere fabbricate. Ci sono delle imprese che le fanno, sono sistemi industriali destinati a questo scopo, alla realizzazione dei vari strumenti che servono al mondo dei lanciatori, dei satelliti e delle stazioni a terra. Un comparto importantissimo di questo mondo. Tra i popoli che se ne occupano attivamente, i francesi sono bravissimi nel mondo dello spazio.
G.G. – A questo mondo dello Spazio proiettato verso l’esterno, se ne accompagna un secondo, un altro pilastro fondamentale, cruciale del settore.
G.P. – A tutto si aggiunge il Downstream rappresentato da tutte le implicazioni e le attività che il navigare nell’outer space consente all’uomo. Tutto ciò gira attorno a un segmento particolare che diventa sempre più importante che è l’osservazione della Terra. I satelliti osservano il nostro pianeta e la servono. Da sottolineare che lo spazio dal quale viene osservata la Terra appartiene sia ai civili che ai militari. Questi ultimi sono quelli che hanno dato il via allo Spazio in termini moderni, basti considerare che ai tempi del grande confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, le apparecchiature che hanno consentito questo balzo in avanti per fare il primo satellite e poi di andare sulla Luna, erano frutto dei progetti di due ingegneri connessi strettamente a progetti militari.
La corsa allo Spazio, un accenno a quella storia che ha determinato un settore economico oggi in potente crescita
G.G. – E qui passiamo per forza a una pennellata storica. Facciamo i nomi di chi ha determinato il successo dei lanci e, quindi, l’avvio della corsa allo Spazio con la conseguente nascita di una grande industria globale.
G.P. – Uno di questi ingegneri era Wernher Magnus Maximilian von Braun, colui che iniziò come militare sotto la Germania nazista, da maggiore delle SS, ideatore dei missili-bomba V1 e V2 sviluppati in laboratori nel villaggio di Peenemünde nel nord-est della Germania, sul Mar Baltico. Razzi che servirono a bombardare Londra. Con la Guerra verso la fine e la Germania soccombente, von Braun passò agli Stati Uniti raggiungendo in maniera fortunosa l’ovest della Francia. La sua opera fu poi decisiva per i lanciatori americani che, prima di lui, utilizzavano i modelli Vanguard del tutto inefficienti e fallimentari. Da parte russa c’era un ingegnere altrettanto geniale, un ucraino, Sergej Pavlovich Korolev, un colonnello dell’Armata Rossa, il padre dei lanciatori russi, i primi a entrare in orbita e che nel 1957 lanciarono con successo il primo satellite artificiale, lo Sputnik. I due si conoscevano, ma non si erano mai visti, divisi su fronti opposti. Quando l’Armata Rossa ebbe il sopravvento sulle forze naziste, Korolev arrivò ai laboratori abbandonati di von Braun a Peenemünde e vide i modelli che il tedesco aveva lasciato lì fuggendo. Korolev, per quanto era geniale non aveva certo bisogno di aiuto, ma si ispirò al lavoro di von Braun.

G.G. – Tutto questo per far capire che in origine lo Spazio ha avuto come suoi primi utilizzatori e padroni proprio i militari.
G.P. – Questo è il punto e i militari ancora adoperano lo Spazio. Se lei va nei consigli di amministrazione delle agenzie spaziali trova un rappresentante delle Forze Armate. Ai miei tempi in Italia era un ammiraglio. Lo spazio serve a loro perché fanno intelligence, devono spiare gli altri, capire quali sono le forze in campo: in questo i satelliti sono fondamentali. La prima matrice è stata militare. In Europa la “scuola” francese è d’esempio. Oggi, anche per risparmiare sui costi, diversi satelliti sono dual-use, a doppia utilizzazione civile e militare. Come i satelliti COSMO-SkyMed, anch’essi dual-use, voluti per l’osservazione della Terra dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal ministero della Difesa italiano (ndR: dotati di sensori radar ad alta risoluzione per osservare la Terra giorno e notte, a prescindere dalle condizioni meteorologiche). Tanto per capirsi, i militari non sono più dominanti in questo settore, ma continuano a essere molto importanti.
G.G. – A questo punto, quali nazioni spendono di più per lo Spazio?
G.P. – In Europa e nel mondo, la Francia è, dopo gli Stati uniti, il Paese che spende la quota più alta del suo PIL, del suo Prodotto interno lordo, per lo Spazio. Sempre in proporzione, supera persino la Cina. La Francia ha sempre molto investito nel settore, da Charles de Gaulle in poi, come ha sempre fortemente investito anche sul nucleare, tanto che buona parte dell’energia che consumiamo in Italia è francese grazie alla produzione transalpina dal Nucleare.
Space Economy, le applicazioni e servizi terrestri, dalle telecomunicazioni all’osservazione della Terra: il grande business è qui
G.G. – Se una parte della Space Economy è l’Upstream, quindi fabbricazione di lanciatori, satelliti e similari, poi segue il Downstream che oggi ha primaria importanza.
G.P. – Qui si passa alle applicazioni. La prima clamorosa applicazione che ha consentito lo sviluppo di un mercato, diventato poi enorme, riguarda le telecomunicazioni. Se lei ha sottoscritto abbonamenti televisivi in qualsiasi forma e se abbiamo centinaia di canali, il fatto è dovuto all’esistenza di satelliti geostazionari che girano attorno alla Terra al suo stesso ritmo (ndR: a 35.863 chilometri di quota nel piano equatoriale terrestre) e nel cielo sono individuabili come punti fissi. Questo è stato il primo grande impulso che si è avuto nel mercato, una grande fonte di reddito. Anche per comunicare, per esempio, da Milano a Roma e trasmettere immagini, evitando di mettere grandi antenne sui monti più alti, il grande traguardo è stato quello di piazzare satelliti geostazionari che ricevono video da tutto il mondo e li rimandano a terra.
G.G. – Telecomunicazioni, comunicazione, ma il grande business della Space Economy è andato ben oltre.
G.P. – Naturalmente c’è una larga fetta economica che riguarda le applicazioni satellitari. Basta pensare alla navigazione: se lei ha un navigatore quando va in auto, è frutto dell’applicazione di connessioni dallo Spazio. Anche questo è un grande mercato. Poi il mercato delle immagini e di rilevazione a terra per comprendere lo status delle acque per capirne la disponibilità anche in relazione al fabbisogno, dei ghiacciai, della situazione atmosferica, della condizione dei mari, la rilevazione del riscaldamento e spostamento tettonico. Ma anche per rilevare le potenzialità dei disastri naturali, come i pericoli di inondazioni o quelli dovuti alla subsidenza nei punti dove la crosta terrestre si solleva: questo punto è strettamente connesso con la realizzazione di infrastrutture, ad esempio con la costruzione di ferrovie o di grande condotte d’acqua scegliendo luoghi dove i movimenti della terra non li compromettano nella loro integrità. Anche la nuova e più corretta indicazione dei fondali più stabili dove collocare le pale eoliche affinché siano piazzate in mare, al largo, per non invadere oltre i paesaggi rovinandoli. Ma penso anche alla guida a distanza dei treni e la rilevazione dello status di percorsi ferroviari rilevandone per tempo anomalie strutturali. Tale sistema di applicazioni è in grande sviluppo e qui nascono i fatturati delle società che si occupano di questi settori. Da almeno due anni a questa parte tali applicazioni stanno sempre più richiamando una forte attenzione da parte di investitori nelle attività spaziali.



Le risorse destinate allo Spazio e il caso India che ha sviluppato applicazioni utili a gestire il suo territorio, dall’aspetto sanitario alla scuola
G.G. – Grande crescita, grande movimento di capitali, forti investimenti per un mercato poliedrico e in forte sviluppo, a prescindere dalla presenza o meno del Covid. Ma esistono altri aspetti, altri vantaggi da queste applicazioni dello Spazio?
G.P. – In effetti non esistono solo applicazioni che danno grandi vantaggi economici, ma anche quelle capaci di generare grandi vantaggi sociali. Un grande Paese, fortissimo nello Spazio, è l’India. Nazione enorme con quasi 1,4 miliardi di abitanti, ha una struttura spaziale straordinaria, ha un’Agenzia spaziale che conta circa 20.000 persone. Il loro uso dello spazio segue un bisogno che deve rispondere a problemi drammatici di controllo del territorio, di poter avere informazioni in tempo reale sulla quantità d’acqua disponibile, sull’andamento dell’agricoltura. Adoperano il sistema anche per le scuole e la telemedicina: ogni villaggio con 300-400 persone ha un medico o operatore sanitario che ha una postazione in cui riceve immagini, fa delle visite esplorative come tutti i medici del mondo e se deve fare delle radiografie, le ordina, è collegato con circa 400 grandi ospedali specializzati. Un servizio sanitario nazionale che, grazie al sistema satellitare, raggiunge e serve questa numerosissima popolazione in gran parte sparsa nel territorio. L’India è sorprendente e ha delle applicazioni assolutamente incredibili. Sono talmente bravi che il satellite scientifico italiano, nominato Agile, quello che ha dato un contributo scientifico molto importante fornendo una spiegazione ai famosi lampi gamma, è stato messo in orbita da un lanciatore indiano.
G.G. – Il nostro programma spaziale? Quanto dedica l’Italia a questa risorsa?
G.P. – C’è una stretta connessione tra ESA, l’Agenzia spaziale europea, e l’ASI, l’Agenzia spaziale italiana. Il bilancio italiano non è piccolissimo, anzi è ben importante. Quantificando, è di circa 700 milioni l’anno. Di questi, la metà va all’ESA. Il restante rimane all’ASI. Quel flusso di risorse all’ESA contribuendo all’agenzia europea ha giustificazione perché è stato ritenuto utile e importante, sia per l’aspetto scientifico, l’esplorazione dello spazio, che per la tecnologia: nessun paese singolo sarebbe mai riuscito a raggiungere gli stessi obiettivi che sono stati colti lavorando tutti insieme. Una nota importante: l’ESA è connessa all’Unione Europea, ma è nata prima di questa. Oggi molti programmi come Galileo o Copernicus sono nati dallo stretto legame UE-ESA, però l’Agenzia è nata ben prima. Gli scienziati, quelli che si occupano di esplorazione e Spazio, si sono sempre confrontati e visti anche al tempo della guerra fredda, anche se sorvegliati dai rispettivi servizi segreti. Si scambiavano informazioni scientifiche, con le intelligence dei loro paesi che li spingevano anche per sapere altro dai loro colleghi stranieri. C’è stata sempre una grande tradizione di collaborazione. Quando hanno notato che si stava sviluppando la scienza dello Spazio, che si stava passando dall’Astronomia di terra all’esplorazione, questi scienziati si sono messi subito insieme precedendo la formazione dell’Unione Europea.
Sfruttamento dello Spazio, pericolo accaparramento risorse extraterrestri, quindi attento controllo del rispetto di regole prestabilite
G.G. – Alle realtà industriali connesse all’upstream e a quelle collegate al downstream e alle osservazioni della Terra, se ne aggiungono altre in potenza. C’è un terzo ramo promettente.
G.P. – Questa terza opportunità è ancora da verificare, da esplorare. Riguarda il futuro. Alcuni dei corpi celesti sono pieni di materie prime e rare, quelle che sulla Terra stanno scomparendo. Esistono già delle organizzazioni che, in vista di uno sbarco su questi corpi celesti, si potrebbero (e vorrebbero) appropriare di queste risorse. È un problema difficilissimo. Per principio, lo spazio appartiene all’umanità. C’è un’autorità che sorveglia le attività spaziali, l’Unoosa (link)-United Nations Office for Outer Space Affairs, ha sede a Vienna, diretto dall’italiana Simonetta Di Pippo: questo organismo opera per far rispettare le norme che il mondo dello Spazio si è dato. Tra queste norme, il divieto di navigare nello Spazio con carichi nucleari, tutto ciò che è radioattivo è proibito. Poi il problema di “spazzatura” nello Spazio, lo Space debris: c’è l’obbligo di far registrare tutti i satelliti che vengono lanciati, ma devono essere dotati di un sistema per farli tornare a terra o per collocarli in un’orbita di riposo. In questo c’è una piccola impresa italiana bravissima nell’ideare un sistema del genere, per mettere a riposo i satelliti quando hanno concluso la loro vita operativa.
La realtà italiana dello Spazio, le “vocazioni” territoriali
G.G. – In ultimo, occorre fare una mappa, almeno a grandi linee, dei territori italiani dove ha grande sviluppo la vocazione industriale e imprenditoriale italiana per lo Spazio.
G.P. – Bisogna partire da una grande rete generata dall’Esa, la Nereus per le applicazioni delle tecnologie spaziali nelle regioni d’Europa. Gli Italiani sono ben presenti e con alcune regioni importanti, lì dove lo Spazio è presente e dove le realtà produttive del settore sono molto avanti: la Campania, la Puglia, il Lazio con Roma con un suo sistema industriale ben definito, soprattutto l’elettronica lungo la via Tiburtina e poi la Lombardia. Queste regioni son ben presenti nel consiglio di amministrazione Nereus. In queste regioni, ma non sarà solo in queste, c’è la risposta all’attuale e futura fisionomia dell’industria spaziale italiana con le sue tante applicazioni.
Tra le maggiori e più geniali realtà produttive italiane dello Spazio evidenziate dal professore Giorgio Petroni:
D – ORBIT Spa (link), con sede in provincia di Como. Costruisce satelliti ed è nota per avere messo a punto un sistema di collocazione dei satelliti “esausti” in una “orbita di riposo”. Il fondatore dell’impresa è l’ingegnere Luca Rossettini da poco nominato presidente dell’Associazione italiana delle Imprese spaziali .
SAB Aerospace (link), gruppo di quattroImprese. Oltre alla casa madre italiana le tre rimanenti sono in Polonia, Repubblica-Ceka e Romania. Costruiscono satelliti ed altri tools spaziali. Il Gruppo è stato costruito dal dottor Franco Zucconi già amministratore delegato di Carlo Gavazzi Space passata da qualche anno alla tedesca OHB. Zucconi è anche vicepresidente dell’Associazione italiana delle Imprese spaziali.
SITAEL (link) che costruisce satelliti con un certo successo. La fabbrica è situata a Mola di Bari.
A seguire, le realtà storiche e più “tradizionali” nel panorama della Space Economy italiana:
- Thales Alenia Spazio (link);
- OHB-Italia (link) ex Carlo Gavazzi spazio;
- Officine Galileo-Leonardo Company (link) che costruisce apparecchiature e sensori ottici per satelliti;
- Telespazio (link) -Osservazioni della Terra- del Gruppo Alenia space.



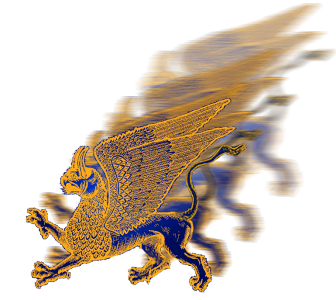




Me n’ero scordato: buon onomastico! 😉
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie! E tra poco pure il compleanno 😀
Li ho a distanza ravvicinata
"Mi piace"Piace a 1 persona
Oddio, mi spaventa: non vorrei mai fossimo nati lo stesso giorno! 🙈
"Mi piace"Piace a 1 persona
22 marzo!
"Mi piace"Piace a 1 persona
No, ci siamo sbagliati di qualche giorno… però siamo entrambi Ariete! 😀
"Mi piace""Mi piace"
Totalmente Ariete!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Non dirlo in giro, ma io… anche un po’ pesce 🤫
"Mi piace"Piace a 1 persona
io ascendente Vergine… ma negli anni me ne hanno dette di tutti i colori su questo connubio di segni, quindi non saprei dire
"Mi piace"Piace a 1 persona
Io non parlavo dell’ascendente… 😉
"Mi piace"Piace a 1 persona
Poi me la spieghi 😁😁
"Mi piace"Piace a 1 persona
hai presente il primo giorno del quarto mese dell’anno? 😉
"Mi piace"Piace a 1 persona
😀 😀
"Mi piace"Piace a 1 persona