È una compagna sempre presente, da quando nasci. Se hai la fortuna di venire alla vita nell’area dell’Etna o Mungibeddu-Mongibbello, il vulcano ce l’hai sempre davanti agli occhi, senti che ti fa tremare la terra sotto i piedi, che ti copre con il suo velo, che illumina le notti di rosso, che all’alba o al tramonto gioca con l’intero arcobaleno dei colori soffiando nuvole immense che spesso fanno da prismi (foto di copertina dalla Protezione civile – Nuccio Sturiale).





Comprendo perfettamente i commenti che da molti mesi leggo sui social. Tutti sbalorditi i non etnei, i non siciliani, gli “esteri”. Sono stupefatti dalle continue eruzioni, da quegli zampilli di roccia fusa come fosse acqua, della coltre di polveri che invade terrazzi, tetti, strade e che mette a dura prova gli scarichi fognari di città e paesi etnei.
Ma è nella sua natura, è l’Etna. Se non facesse così, non darebbe sfogo alla sua grande energia, la accumulerebbe al suo interno e prima o poi la Montagna (a Muntagna) non reggerebbe esplodendo con la potenza di diverse bombe atomiche. L’Etna ci vuole bene e non avrebbe mai il cattivo gusto di esplodere… a meno che non impazzisca.
Da queste mie parole potete subito capire come per noi quel vulcano sia vivo, parliamo con lui, ci confrontiamo, ci tiene in vita da millenni, ma ogni tanto fa disastri (un mio articolo a questo link).





A parte lo scenario apocalittico, ogni etneo convive con tutto questo fin dalla nascita.
Io stesso ho un ricordo appena accennato di un terremoto. Ero troppo piccolo per rammentarne oggi i particolari. Però ho come pezzetti di immagini in 3D sensoriale fermi nella mente.
Una corsa in auto con i miei genitori che ebbero l’accortezza di trasformare tutto in un gioco, in una gita. Infatti, questa mia memoria non è carica di paura o di apprensione, ma di un senso d’avventura. Uno spiazzo grande e aperto, lì sosta in auto nella notte come per altre famiglie: gli adulti erano consapevoli che bisognava essere lontani da palazzi o da qualsiasi altra cosa potesse crollarci addosso.
Un terremoto che, comunque, non fece danni.
Stessa cosa accaduta nel 1968, durante il terremoto della Valle del Belìce, all’altro capo della Sicilia, ben avvertito anche nella parte orientale dell’Isola, pure a Catania.
I tremori, quelli appena avvertibili, invece, si manifestano molto spesso. Non quotidianamente, ma quasi. In periodi “travagliati” per l’Etna, più volte al giorno.
Ma l’Etna domina e non lo fa solo con la sua presenza fisica.
Le estati siciliane seguivano uno schema ben preciso, fin quando ho abitato a Catania, ma anche dopo, nel lungo peregrinare della mia famiglia tra Savona, Parma, Livorno e Crotone, ma pure successivamente al nostro stabilirci nella Capitale, a Roma.
Ovunque fossimo in Italia e in Sicilia, era riunione tra parenti, zii, cugini, nonni.
Estate al mare alla Playa di Catania, lunghissima distesa sabbiosa bionda chiarissima, con due grandi cabine affiancate (quelle attuali sono solo meri spogliatoi striminziti) al Lido Azzurro. Ma anche lungo la scogliera lavica che si sviluppa a nord di Catania, ad Aci Castello, dove imparai bene a immergermi in apnea.
A ferragosto e a settembre arrivava il momento della campagna. Quando si parla di campagna, si intende nelle proprietà arrampicate lungo i fianchi dell’Etna.
Come fare a spiegarvi? Tento di farvi comprendere questa full immersion etnea.
I periodi che rimarranno sempre nella mia mente, catalogati tra quelli più piacevoli e divertenti, riguardano me, i miei cugini Maria e Alfonso, mio fratello Salvatore. Luogo: Ragalna, paese etneo in provincia di Catania, comune a 830 metri sul livello del mare, non lontano dalla più grande Nicolosi.
Le nostre scorrerie a caccia di cavallette? Troppo divertenti. Se ne prendevamo qualcuna, provvedevamo poi a seppellirla con tutti gli onori e con una lapide fatta con un pezzo di corteccia strappata al tronco di un grande Salice.
Correre durante questa e altre nostre “incursioni“, significava affondare i piedi in quella particolare terra granulosa e dal doppio colore. In parte rossiccia-grigia, ma prevalentemente nera. La consistenza? Tra il classico terroso e la prevalenza di piccolissimi granuli duri e neri, frutto del millenario disfarsi di remote colate laviche.
L’odore? Si perché questa terra ha un suo odore particolare.
Provate a immaginare qualcosa di quasi indefinito, un’alchimia tra il salmastro, la pietra pomice bagnata, pietre di selce sfregate tra loro (da sé il minerale non ha odore, ma con lo sfregamento si liberano particelle di zolfo e ferro che un odore lo hanno), stessa cosa per la grafite. Ecco questo può dare un’idea, ma non è proprio completa.
Sappiate comunque che sono sentori al naso e al gusto che questa terra regala anche ai suoi vini, all’Etna Rosso per esempio, anche se lo fa con estrema delicatezza facendo predominare ben altri profumi e sapori.
E il vino mi ricorda che queste corse fatte da bambino e ragazzino in campagna, con i miei cugini, avvenivano spesso tra filari di uva, grappoli fatti di tanti acini piccoli e neri. Grappoli che non uscivano indenni dalle nostre razzie: spesso ci si fermava a mangiare quell’uva. Dolce, poco aspra, spesso già tendente al passito in quegli anni in cui c’era carenza d’acqua… e che profumo quell’uva, il naso la percepiva durante tutti i nostri giochi anche senza avvicinarci.
Era ed è tutt’oggi, tutto forte, marcato, come il sapore delle mandorle che facevamo cadere dagli alberi grazie a duri e secchi bastoni di Ferla (Ferula communis Linnaeus) o come la luce limpida e cocente del sole o come l’azzurro-blu carico di quel cielo, oppure come il verde-turchese di quei mari.
L’Etna era in tutte queste cose, era nei fichi succulenti che raccoglievamo dagli alberi, compreso quello gigantesco che ne faceva di neri con polpa rossissima e zuccherata. Anche le bucce buttate alla base dell’albero, a macerare con le foglie cadute, emanavano un odore particolare, forte, a volte pungente, ma non sgradevole. Faceva campagna.
Adesso, vi rivolgo un invito: portate alla memoria il vostro ricordo sul profumo e sul gusto di un fico. Moltiplicatelo per dieci. Avrete un’idea di quello che ho percepito per innumerevoli anni.
Il terreno lavico non permette soltanto più maturazioni nella stessa stagione, più “mandate” di fichi, ma potenzia profumo e sapore, sensazioni appena contornate da quelle percezioni sul terreno di cui ho scritto prima.
Stessa cosa per ogni tipo di frutto.
A fine giornata quei sentori del suolo li avevamo addosso, eravamo pieni di terriccio dai capelli ai piedi. Energiche lavate ce la portavano via quella terra nera, ma il suo profumo rimaneva, era nel naso.
Era anche nella dolce salsa di pomodoro della pasta, nell’olio fresco, piccante, gustosamente pieno che sembrava richiamare anche il sapore delle mandorle. Nel pane cotto dalle mogli dei contadini.
Il pane, che buono.
Semola di grano duro. Dava alla pagnotta un colore bruno giallastro all’esterno e una mollica gialla non appena le tagliavi. La versione “a ciambella” di quel pane, col buco in mezzo, si chiamava e si chiama Cucciddatu.


Prima immagine, il Cucciddatu – foto di Laura Distefano. Secondo scatto, sempre pagnotte di semola di grano duro, ma non “a ciambella” come è il Cucciddato
Qui entra in scena una di queste donne contadine cui ho accennato, la signora Elena, bella corpulenta. La ricordo sempre con un fazzoletto in testa, mai senza, almeno fuori dalla sua casa. Braccia potenti, peluria sul labbro superiore, donna dolcissima.
Lei faceva pagnotte piene, non quelle a ciambella. Le preparava dall’inizio alla fine, dall’impasto fino alla cottura in forno. Avevano un profumo e un sapore che non ho più incontrato.
Instancabile, Elena impastava in questo ambiente scuro con un grosso forno acceso. Chissà che temperatura c’era lì dentro: a settembre, all’esterno, l’ambiente era cocente. Io mi ci squagghiavo (squagliavo) dentro a quella casa. Ma osservarla mentre faceva il pane era uno spettacolo.
E lei impastava pagnotte su pagnotte, poi dava loro forma, quattro leggere incisioni a forma di quadrato intorno al centro, tagli praticati con un coltello, anche qualche infilzata con la forchetta, una preghiera e poi via, nel forno a legna.
Quando la signora Elena le tirava fuori cotte, c’era un primo assalto di odori al naso. Queste sensazioni non so descrivervele a parole. So solo che mi si apriva letteralmente lo stomaco. La fame arrivava all’istante.
A quel punto due le scelte possibili.
Gustarsi subito un po’ di quel pane, ancora bello caldo o aspettare il pranzo resistendo alla tentazione di azzannarlo durante il ritorno in villa: come sembrava lungo quel ritorno con la pagnotta profumatissima nel sacchetto! Pochi passi sembravano mille. Una tortura.
Secondo voi cosa facevo il più delle volte?
La cosa più azzeccata era (ed è) tagliare subito una fetta di pane, metterci sopra un po’ d’olio etneo, un pizzichino di sale e (io lo consiglio) una spolveratina di origano… ovviamente etneo.
Roba da mangiarne a tonnellate. Noi bambini bruciavamo energie durante tutta la giornata e di certo non correvamo il rischio di ingrassare.
Comunque, un altro dei massimi godimenti (per me carico di nostalgia: non lo faccio da anni) era gustare quel pane durante il pasto di metà giornata, accompagnando dell’ottima carne (o del pesce come fette di pesce spada) arrostita sulla carbonella, bagnata più volte durante la cottura col Salmoriglio-Sammurigghiu, spennellando con un ramo di rosmarino fresco.
Il Salmoriglio è fatto con olio d’oliva precedentemente preparato in una ciotola: sbattuto con un cucchiaio insieme a limone, prezzemolo, un tocco d’aglio tritato, origano (noi non ci mettevamo il peperoncino, ma qualcuno lo faceva e lo fa).
In tutto questo concerto di sensazioni e situazioni, di colori e sapori, c’era (e c’è) l’Etna, in ogni sfumatura visiva e sensoriale in genere.
L’Etna sta pure in ogni chiesa, strada, palazzo, casa, grazie alla pietra lavica utilizzata in più forme e in tantissimi modi.
Il suolo tremava e trema ancora oggi? Sì, è vero. Il vulcano è vivo, respira, si fa sentire anche con i boati e con i suoi movimenti.
Li ricordo da sempre. Fa parte della quotidianità in quella parte di Sicilia.
Ma attenzione, non fatela passare come una forma di indolenza, di abitudine, come se si volesse sottovalutare il fenomeno. L’orecchio e le gambe percepiscono e sanno distinguere la pericolosità o meno degli istanti.
Tutti noi etnei siamo un po’ come quelle complesse macchine che, sparse sulla Montagna, sorvegliano ogni attimo di vita vulcanica per contro di geologi e scienziati del settore.
Un mio suggerimento.
Dovete provare a vivere per un po’ sull’Etna o intorno a essa.
Allora sì che vi accorgerete del suo profumo e di come il suo calore vi penetrerà nell’anima. La Montagna non è solo il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica… non è solo lava, fumo, tremori, polveri e fuoco.
È unione tra il cielo, il mare, la terra e il cuore del nostro Pianeta. È il tramite tra la pelle e l’anima della Terra. Noi etnei lo sappiamo bene. Lo percepiamo pienamente nel nostro intimo.
E nel Muncibeddu abbiamo forgiato il nostro carattere, così tanto che gli assomigliamo parecchio nella passione per ogni cosa – pur sembrando spesso calmi e tranquilli -, a cominciare dall’amore e dalla dedizione assoluta. Ma non illudeteci, non traditeci e non trattate i nostri sentimenti come uno scarto, come qualcosa che si può tagliare facilmente e gettare via, perché son dolori e oblio (reciproci).
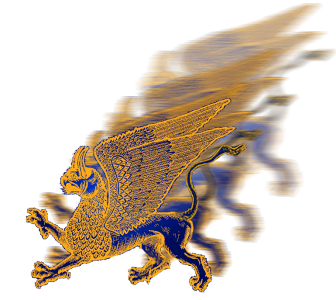
Ricordo lo stupore, ero a Taormina, nel trovare sul terrazzino dell’hotel quella distesa di minuscoli granelli neri. Il mio primo pensiero fu guardare in alto (chi è sto cafone che mi ha buttato sta roba di sotto?).
Ma ero all’ultimo piano. La Montagna aveva la tosse e, anche così lontano, ci se ne accorgeva.
"Mi piace"Piace a 1 persona
😄😄 vero, vero. Non hai idea di quante volte ne abbiamo raccolta a palettate. E le auto ricoperte? Che poi devi togliere questa polvere, questo terriccio, con estrema cautela altrimenti graffi ogni superficie (per la verniciatura delle carrozzerie è un dramma). Tre volte tornando a Catania mi è capitato di trovarmi come nei paesi innevati, solo che invece della neve era cenere etnea
"Mi piace"Piace a 1 persona
E come ci si slitta sopra con l’auto!
"Mi piace"Piace a 1 persona
E come c’è da far controllare e sostituire i filtri dell’aria!
"Mi piace""Mi piace"