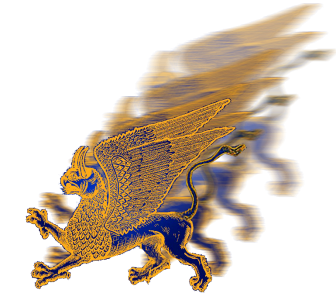Metti insieme un pianista di primo livello nazionale e internazionale con le musiche di Scarlatti, Schubert, Beethoven, Chopin, Bellini, Liszt, Debussy in un contesto d’arte creato nell’ambito di iniziative per la diffusione delle conoscenze musicali e di incontro con la creatività. Con questi ingredienti ottieni un un sodalizio vincente: il Maestro Vincenzo Balzani, che sarà l’interprete del Concerto per la Pace -13 aprile ore 18,30 Sala Sodano di Palazzo d’Alì a Trapani-, con l’Associazione Musicale e Culturale “Trapani Classica” (link pagina Facebook), presieduta dal Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, realtà che ha progettato una stagione concertistica e di masterclass di primissimo livello artistico.


“Ho insistito nel dedicare il concerto alla Pace visto quanto sta accadendo oggi – dice il Maestro Vincenzo Balzani – Una cosa grande fatta dal Papa è stato consacrare il popolo russo e il popolo ucraino al Sacro Cuore della Madonna di Fatima: non ha consacrato né l’Ucraina, né la Russia, ma i due popoli perché è l’unica cosa possibile. In questa tragica vicenda, coloro che stanno veramente soffrendo sono i popoli”.
Il concerto del 13 aprile è un vero e proprio dono del Maestro Balzani, già presente a Trapani per un corso di alto perfezionamento pianistico in tre sezioni, inserito nel cartellone degli eventi musicali di “Trapani Classica”, il tutto programmato al Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani per l’11, 12 e 13 aprile. La masterclass è aperta agli studenti interni e ai pianisti esterni.
Nel 2009 Balzani ha fondato a Milano l’Associazione “Pianofriends” (link) di cui è direttore artistico, per poter realizzare festival, concerti, stage e seminari.

“Trapani Classica viene considerata in questo momento da tantissimi intellettuali del nostro paese un esempio di virtù, talento, visione e grandi competenze – sottolinea il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, presidente di Trapani Classica – Il pubblico Trapanese con gioia risponde con il tutto esaurito ad ogni evento proposto. Un fiore che cresce, lontano dalle solite logiche italiane. Non ci sono scambi, non ci sono raccomandati. Qui esiste soltanto il talento che viene supportato con tutto l’amore possibile. Siamo un gruppo di visionari felici di rendere il mondo vicino sempre più bello”.
Gli eventi di “Trapani Classica” sono realizzati in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale, il Conservatorio di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani e con l’Assessorato alla Cultura di Trapani.
Programma del “Concerto per la Pace”, 13 aprile ore 18,30 a Palazzo d’Alì, con il Maestro Vincenzo Balzani
– Domenico Scarlatti, 3 sonate
(K62 la maggiore – k141 re minore – k455 sol maggiore)
– Ludwig van Beethoven, sonata op.27 n.2 do diesis minore “Al chiaro di luna”
– Franz Schubert, impromptu op.90 n.4 la bemolle
– Frederick Chopin, ballata in sol minore op.23
– Vincenzo Bellini, “Casta Diva” (trascrizione per la mano sinistra sola di Adolfo Fumagalli)
– Franz Liszt, Polonaise in mi maggiore
– Claude Debussy, 3 preludi dal secondo libro
(Bruyeres, Ondine, Feux d’ artifice)
A seguire il link al file pdf con la Guida all’ascolto a cura di Anna Maria Malerba, musicologa e docente di musica, segretario di “Trapani Classica”:
Balzani, l’intervista
L’istinto, la conoscenza, il confronto, questi i tre capisaldi che per il pianista Maestro Vincenzo Balzani fanno grande un concertista, un artista delle note. Ma non è stata una consapevolezza presto raggiunta. L’inizio del suo rapporto con la musica e il pianoforte è stato dettato dal fascino per l’arte musicale e dall’istinto. Poi l’incontro con alti interpreti e maestri, fattore che gli ha permesso di avere i giusti strumenti e le corrette impostazioni per ottenere il meglio da se stesso.


“Nelle famiglie meridionali, i miei e i nonni erano napoletani, il bisnonno era un avvocato dell’epoca Borbone, si approfondivano molto gli studi – racconta il maestro – Nella mia famiglia era mia madre a studiare pianoforte: ne rimasi fortemente incuriosito e affascinato. Quindi, intorno ai miei nove anni, mia madre, grazie a sue conoscenze, contattò un maestro al quale chiese se fosse stato possibile venire una volta a settimana per darmi lezione visto che avevamo già un pianoforte in casa”.
Giuseppe Grifeo – Tutto ebbe inizio in quel momento. Come crebbe nell’arte musicale, nel “dialogo” con il pianoforte?
Vincenzo Balzani – “Ricordo che suonavo con una certa facilità, però questo maestro passava il tempo a dormire mentre eseguivo dei pezzi: metteva degli occhiali neri e si appisolava. Mi dava poche indicazioni di base e non di più, anche se veniva dalla celebre scuola napoletana, allievo di Calace. Arrivò a venire in casa ogni giorno, cenava da noi, era praticamente di famiglia. Era un uomo molo solo”.
G.G. – Quindi era necessario un cambiamento, quello che si potrebbe definire come un decisivo cambio di marcia.
V.B. – “Dopo tre anni che studiavo con lui, le stesse amiche di mia madre, quelle che avevano consigliato questo professore, arrivando in casa la presero da parte e le fecero capire che non avevo fatto alcun progresso. Anzi, ero diventato molto disordinato. Mi sentivano fare pezzi sempre più difficili e il disordine nelle mie esecuzioni lievitava. Con quella consapevolezza che venne solo dopo diverso tempo, con l’esperienza e che tutti conosciamo, il disordine nasce fin dall’inizio: se non si corre subito ai ripari, scoppia in una catastrofe. Mia madre voleva farmi superare l’esame del quinto, il compimento inferiore, doveva quindi verificare. Così, sempre su consiglio delle stesse amiche, prese appuntamento col grande Maestro Alberto Mozzati. Lì fu il momento di vera svolta”.
G.G. – Il Maestro Mozzati era celebre. Non vedente, era un grande personaggio della musica e professore al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
V.B. – “All’audizione feci sentire a Mozzati tutto il programma che avevo preparato, tutto il Chiaro di Luna di Beethoven, la prima grande opera che ho studiato nella mia vita. Il Maestro fu limpido con mia madre: Suo figlio deve fare l’esame adesso, forse sì, ha la mano che cammina, va veloce, ma sembra che non capisca quello che sta facendo. Se passerà l’esame, sarà per il rotto della cuffia. Se avesse un pochino di tecnica in più, potrebbe suonare molto meglio. Se vuole, sono disponibile, e sentirlo una volta alla settimana. Appena ne fu informato di tutto questo, il maestro che mi seguiva in casa rimase deluso e sparì per sempre”.
G.G. – Un lavoro di comprensione di se stesso e della musica tutto da iniziare. E doveva farlo con una certa rapidità in vista dell’esame. Quanto ci mise?
V.B. – “Nell’arco di sei mesi il Maestro Mozzati mi mise in riga, mi cambiò tutte le diteggiature, tutte le pedalizzazioni dei pezzi. Mi costrinse a studiare lentissimamente, nota per nota, con un sistema che, come scopersi anni dopo, era di Sergej Rachmaninov: sentire ogni minimo movimento che compie il dito, il polso, il braccio, la scioltezza ecc. Tutte cose connesse a una corretta impostazione dei pezzi. A quel punto, dopo sei mesi, non ancora quattordicenne, ho fatto l’esame di quinto con il concertista Carlo Vidusso (ndR: grande pianista e maestro, dotato di tecnica eccezionale e leggendaria facilità di lettura) che era presidente della commissione. Un personaggio molto severo. Avevo portato dieci studi di Chopin. Estrassi uno dei dieci studi di tecnica, l’11 opera 25. Iniziai a suonare e… Vidusso stava scrivendo. Sembrava poco interessato. Poi mi venne vicino e ascoltò con attenzione. Mi chiese: Lei fa anche lo studio delle doppie terze. Me lo farebbe? Lo so che è fuori programma. Al che suonai quel che lui voleva. Vidusso notò che c’era la sua diteggiatura, quella usata da Mozzati non vedente anche per comodità nelle lezioni con gli studenti… e poi perché era una modalità perfetta. Il Maestro si accorse pure che in una scala cromatica io mettevo una diteggiatura diversa, una cosa che lo rese molto contento anche dopo le mie spiegazioni: era il segno che suonavo con una certa coscienza, con consapevolezza di quel che interpretavo. Dopo tutto questo posso quindi sottolineare che Alberto Mozzati mi ha dato quella piena coscienza che la musica poteva essere tutto per me”.


G.G. – Alla luce di quella esperienza iniziale, quali sono gli strumenti e le qualità per chi approccia lo studio e deve portarlo avanti?
V.B. – “Per i primi tre anni mi ero avvicinato alla musica solo con l’istinto, senza una guida chiara. Però l’istinto da solo non basta. Il talento è difficile da definire: è un insieme di tanti fattori, una somma di istinto, di consapevolezza, di conoscenza. Ma anche la disciplina è fondamentale”.
G.G. – Da quel momento per lei fu una continua e inarrestabile crescita.
V.B. – “Dopo i successi degli anni 70, Marcello Abbado nel 1972 mi chiese di partecipare a questi concorsi che si facevano per iscritto mandando tutti i dati con i concerti fatti, le critiche sul proprio operato e io ne avevo già più di un centinaio: di questi, 51 concerti furono il primo premio che conquistai vincendo il concorso Città di Treviso nel 1971, solo a rimborso spese ma assicurava presenze in tutte le città italiane, alcune all’estero. Un’ottima spinta. Anche perché per un musicista la cosa più importante è comunicare, trasmettere quello che studia. Se non c’è il pubblico di fronte, tutto quello che noi facciamo diventa un pochino sterile”.
G.G. – Da lì l’arrivo alla cattedra di pianoforte principale che ha dato maggiore consapevolezza e ha rafforzato i punti cardine del percorso di formazione per i suoi allievi. Studiare, tanto, approfondire, confrontarsi con gli altri. Iniziare sì, ma quando, a che età per un risultato migliore e più promettente?
V.B. – “È importante iniziare presto, è una concezione che abbiamo in comune in tanti, come con l’amica e pianista Maria Tipo. Concorda anche il concertista Carlo Bruno parlando del grande pianista e maestro Vincenzo Vitale del quale fu allievo tra i dieci e gli undici anni. Da piccoli è più facile indirizzare l’allievo verso la migliore costruzione di un brano musicale: prima di tutto bisogna capire cosa è. All’inizio il vero musicista non dovrebbe neppure leggerlo al pianoforte, ma scorrerlo e comprenderlo allo spartito. Solo dopo il musicista deve andare al pianoforte dando una lunga prima lettura cercando di interpretarlo. Per rifinirlo c’è un unico sistema, quello di diteggiarlo perfettamente, di mettere una buona pedalizzazione e seguire il fraseggio. Il fraseggio, la notazione, è la cosa più importante che noi dobbiamo tentare di analizzare e seguire con grande attenzione”.


G.G. – I giovani di oggi e la spinta a diventare grandi della Musica: quali errori vengono commessi più facilmente e cosa fare per evitarli?
V.B. – “I ragazzi oggi non comprano più gli spartiti, vanno su Petrucci, su Imslp e prendono la prima edizione che vedono, la scaricano e la studiano. Fanno questa cosa con un pezzo di Bach, di Mozart o di Beethoven. Però in questo modo rischiano di impostare mentalmente un fraseggio che non è quello di edizioni originali, non è quello visto da un grande maestro, oppure è molto datato e può avere degli errori. Bisogna avere la pazienza di sapere e di analizzare quello che è stato scritto, senza pescare quel che capita prima. Oggi abbiamo tutti i mezzi tecnici per farlo. Dobbiamo avere la possibilità di caratterizzare il nostro pensiero perché i cosiddetti colori, che poi sono segni sia timbrici che dinamici, sono da comprendere all’inizio dello studio secondo i desideri dell’autore. Dopo di che, c’è molto spazio disponibile per l’interprete”.
G.G. – A questo punto occorre dare un esempio, un’indicazione.
V.B. – “Un esempio viene da un metodo che amo molto, l’opera di Carl Czerny in quattro parti: uno è un supplemento che indica come si deve interpretare la musica pianistica di Beethoven. Nei tre fascicoli precedenti al supplemento, quasi 500 pagine e nel terzo di questi dedicato all’interpretazione, Czerny fa una disamina perfetta di come dobbiamo imparare a scindere la timbrica dalla dinamica e dall’agogica. Nei seminari parto sempre dal trattato di Francesco Pollini che è il più antico esistente in Italia, è del 1811. Passo poi per Czerny e arrivo ai Modi di valore e di intensità (Mode de valeurs et d’intensités) di Olivier Messiaen del 1949, dove l’autore, prima dello studio, inserisce le tre serie, quella dei timbri, quella delle dinamiche e quello del ritmo o dei valori ritmici: questo è un pezzo pre-strutturalista, ci sono non solo le serie dei 12 suoni, ma utilizzate a giostra, come nella musica dodecafonica. Solo a leggerle, queste poche pagine dello studio rivelano grande complessità”.
G.G. – Ma non è finita qui con i passi necessari allo studio e alla preparazione necessari alla creazione della propria personalità musicale.
V.B. – “Il percorso della formazione e del lavoro passa anche dal confronto tra gli interpreti. E qui devo molto sempre a Mozzati. Lui aveva una grande collezione di dischi. Una volta a settimana si ritrovavano da lui Giulio Confalonieri, musicologo e compositore, Alberto Zedda, musicista e direttore d’orchestra insieme ad altri amici. Di volta in volta si prendeva un autore e un’opera e si ascoltavano diverse interpretazioni della stessa. Questi appuntamenti si trasformavano in sorta di concorsi a tema. Una volta fui invitato e si doveva discutere sulla Sesta sinfonia di Tchaikovsky. Il maestro aveva dischi e registrazioni da Toscanini a Willem Mengelberg: quella che vinse fu la registrazione di Evgeny Mravinsky con la Filarmonica di Leningrado. Questa esecuzione era una cosa straordinaria. Per quanto riguarda il pianoforte mi sono abituato a cercare di mettere spesso a confronto gli interpreti per evitare le storture che avvengono quando i ragazzi vanno a scaricare la prima edizione che capita loro, come su YouTube, dove pescano la prima in cima alla lista o la più gettonata, anche perché abbinata a un video… mentre le edizioni di maggior valore sono più in basso nella lista. In breve, se io ascolto dieci esecuzioni diverse di grandi del passato e del presente, mi posso fare un’idea migliore, veramente personale, su come possa essere il pezzo. È come se io per andare a cercare casa ne vedessi tante. Magari ci sarà pure un momento in cui non saprei quale scegliere. Però, più io riesco ad avere davanti a me la storia dell’interpretazione attraverso l’ascolto dei vari interpreti, più riesco a migliorare la mia personalità interpretativa e artistica. Non ampliando la personale visione e il confronto, il risultato sarà molto limitato. Bisogna vedere il futuro nel passato. Un parallelo è anche con l’attualità, l’errore tragico con la crisi in Ucraina: innanzitutto il presente nel passato, otto anni fa quello che già stava accadendo, ma tutto viene anche da molto più lontano”.
“Ho insistito nel dedicare il concerto alla Pace visto quanto sta accadendo oggi – conclude Vincenzo Balzani – perché è giusto che un popolo si difenda da un assurdo aggressore, ma inviare le armi mi mette grande disagio: io stesso se mi trovassi nella situazione di dover firmare per inviare armi, sarei molto a disagio. Una cosa grande fatta dal Papa è stato consacrare il popolo russo e il popolo ucraino al Sacro Cuore della Madonna di Fatima: non ha consacrato né l’Ucraina, né la Russia, ma i due popoli perché è l’unica cosa possibile da fare. In questa tragica vicenda, coloro che stanno veramente soffrendo sono i popoli”.


Il “chi è” del Maestro Vincenzo Balzani
Milanese di nascita, ma Napoli nel sangue, Balzani ha percorso tappe importanti a contatto con grandi della musica italiana ed estera, esperienze che lo hanno arricchito da quando a 14 anni vinse i concorsi pianistici di La Spezia (E.N.A.L.) e “Förster – Ricordi” di Milano.
Dopo importanti traguardi in concorsi nazionali e internazionali in Italia, nel 1975, l’anno del centenario della nascita di Maurice Ravel, ha rappresentato la Rai nella rassegna-concorso all’ORTF- Office de Radiodiffusion Télévision Française di Parigi segnalandosi tra i primi.
Da quel momento Balzani ha calcato le scene di celebri teatri e sale nel mondo, presente alla Scala di Milano, al San Carlo, al Petruzzelli, al Regio di Torino, all’Olimpico, al Festival di Bergamo e Brescia, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Settembre Musica e a tantissimi altri appuntamenti. Presenze sia in veste di solista che con orchestre e in formazioni cameristiche dal duo al settimino.
Dal 1973 titolare della cattedra di pianoforte principale, ha insegnato al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.
Per una visione completa sulla carriera del Maestro, basta leggere/scaricare il suo curriculum vitae al link successivo:
“Concerto per la Pace”
Sala Sodano di Palazzo d’Alì a Trapani
Recital, 13 aprile 2022 alle ore 18,30
prenotazione obbligatoria su www.trapaniclassica.it
Contatti
Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, presidente dell’Associazione Trapani Classica
+393386199250
spazio Facebook: https://www.facebook.com/trapaniclassica
email: associazione@trapaniclassica.it