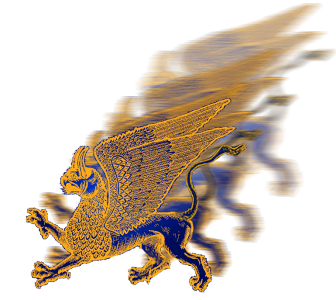Ho un rapporto viscerale col cibo e col vino (sì, è proprio il caso di dirlo: quanto mai perfetto oltre che divertente): lo amo, lo racconto perché significa anche narrare territori e tradizioni oltre ai sapori che mi stupiscono da sempre, come quando da bambino mi regalavano un giocattolo o un soldatino.
Naturalmente, si cresce, i decenni si accavallano e bisogna fare una scelta che è frutto di una domanda: volendo continuare a divertirmi col gusto, con l’assaporare? Però, come continuare a farlo evitando di trasformarmi in una mongolfiera ripiena di grasso?







La risposta sarebbe quella di fare movimento e dieta. Personalmente a questi dedico buona parte della settimana ritagliando momenti molto gustosi nei fine settimana e/o per esigenze di lavoro (altrimenti che racconto? Il retrogusto fruttato di un sedano accompagnato da acqua minerale… liscia?.. NO). A questo punto è meglio intendere dieta – δίαιτα nel suo significato originario tradotto dal Greco: modo di vivere, adatto a mantenere lo stato di salute.
Occorre equilibrio anche nelle diete.
Una dieta che mi aiutò la applicai da gennaio 2011: in tre mesi e una settimana mi fece perdere ben 15 chili circa. In cosa consisteva? Nel dimezzare le mie solite portate senza privarmi di nulla.
La varietà degli alimenti rimaneva, ma con forte limitazione sulla quantità. Andai oltre solo con i formaggi che diminuii in misura maggiore. Il risultato fu fantastico.
Personaggi del passato avevano precise idee sulle diete e sul gustare, la complementarietà di anima e corpo, il cibo come nutrimento anche per l’anima e la migliore alimentazione per una superiore percezione del proprio corpo (e delle sue vere esigenze), la semplicità dei pasti… senza dimenticare saltuarie incursioni in tavolate elaborate. Ci sono pensieri ed esperienze per tutti i gusti. Però Seneca sembra essere l’unico a contraddirsi.
“Diffidate delle diete, una salute conservata con una dieta troppo severa è come una noiosa malattia”.
Il filosofo, giurista e storico Charles-Louis de Secondat, Barone de La Brède et de Montesquieu (La Brède, 18 gennaio 1689 – Parigi, 10 febbraio 1755)
“L’uomo è ciò che mangia”.
Ludwig Feuerbach, filosofo tedesco (Landshut, 28 luglio 1804 – Norimberga, 13 settembre 1872)
“Mann ist was er isst”.
“Allorché affermiamo che il piacere è il fine, non facciamo riferimento ai piaceri dei dissoluti e a quelli che risiedono nel godimento dei sensi – come ritengono alcuni ignoranti che non sono d’accordo oppure che interpretano malamente –, ma il non soffrire nel corpo né turbarsi nell’anima. Non sono infatti le bevute e i continui bagordi ininterrotti, né il godimento di ragazzini e donne, né il gustare pesci e altre cibarie, quante ne porta una tavola riccamente imbandita, che possono dar luogo a una vita piacevole, bensì il ragionamento assennato, che esamina le cause di ogni scelta e repulsa, e che elimina le opinioni per effetto delle quali il più grande turbamento attanaglia le anime”.
L’antico filosofo greco Epicuro-Ἐπίκουρος (Samo, 10 febbraio 341 a.C. – Atene, 270 a.C.) nella Lettera a Meneceo (sulla felicità)









“Mi piace un cibo che non debba preparare e sorvegliare la servitù, che non sia stato ordinato molti giorni prima né sia servito dalle mani di molti, ma facile a procurarsi e semplice, un cibo che non abbia nulla di ricercato o di sofisticato, che si possa trovare da qualsiasi parte, che non sia pesante né per il patrimonio né per lo stomaco, che non ritorni da dove è entrato. Mi piacciono il servo alla buona e lo schiavetto rustico, l’argenteria massiccia del padre contadino senza alcuna firma di artista, e una tavola non pregiata per la varietà delle venature né famosa in città per il continuo susseguirsi di padroni raffinati, ma fatta per essere usata, e tale da non attirare su di sé, con il piacere che offre, gli occhi di alcun commensale né li accenda di invidia”.
“Quando sono completamente soddisfatto di queste cose, ecco, mi abbagliano l’eleganza di uno stuolo di paggetti, i servi vestiti con più cura che per una processione e ornati d’oro e una schiera di splendidi schiavi, e poi una casa preziosa anche là per dove si cammina e persino i soffitti splendenti in mezzo a ricchezze sparse in ogni angolo e la gente che segue e accompagna patrimoni destinati a sfumare; e che dire delle acque trasparenti fino al fondo che scorrono proprio intorno alle tavole da pranzo, e che dire dei banchetti degni del loro scenario?”.
“Dopo il lungo letargo della mia frugalità, il lusso mi assale con il suo splendore e mi frastorna da ogni parte: la vista un poco vacilla, contro il lusso mi appello più facilmente al ragionamento che agli occhi; me ne ritraggo, dunque, non peggiore ma più amareggiato e non più così orgoglioso tra quelle mie povere cose e un assillo segreto mi prende e il dubbio che quelle altre possano davvero essere migliori. Nulla di tutto ciò mi cambia, eppure tutto mi sconvolge”.
“[…] Affinché l’animo infine sia pronto per le cose più ardue, è giusto svagarlo con giochi e riposo; salutari potranno essere le passeggiate all’aperto per respirare liberamente, e anche stordirlo di tanto in tanto di vino, purché non sia sommerso nell’ubriachezza”.
Lucio Anneo Seneca, nel Ad Serenum de tranquillitate animi, filosofo, drammaturgo e politico dell’antica Roma (Corduba, 4 a.C. – Roma, 19 aprile del 65 d.C.)